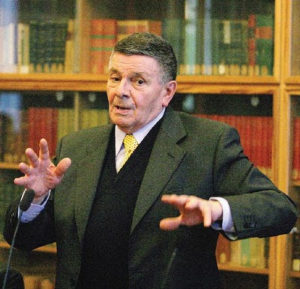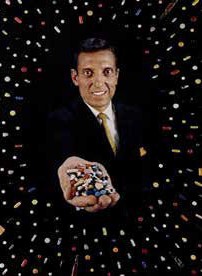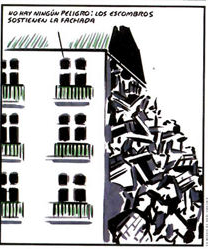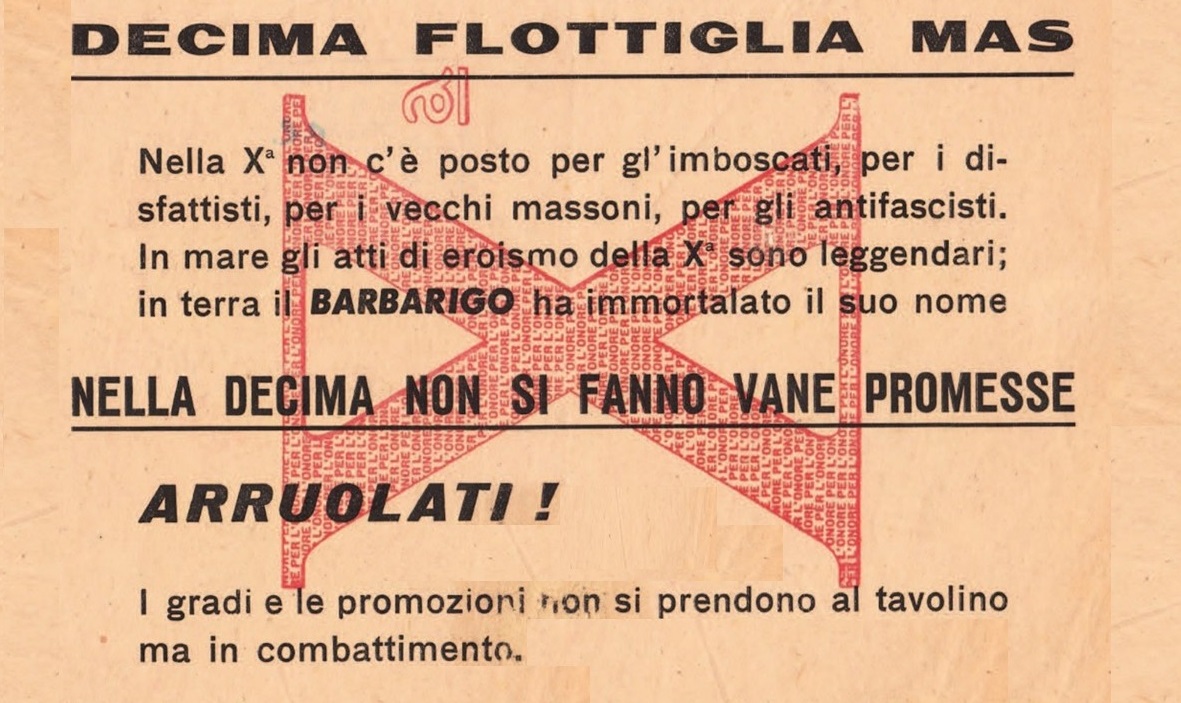Nel libro “The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783”, pubblicato nel 1890 da Alfred Thayer Mahan, l'autore ricerca una stima dell'effetto del potere navale sul corso della storia e sulla prosperità delle nazioni. Nella prefazione viene citato lo storico Arnold, autore della “Storia di Roma”, che accosta Scipione a Wellington. Entrambi impegnati a combattere in Spagna per lunghi anni, lontani dai principali teatri di guerra, sconfiggeranno tutti i generali nemici in sottordine prima di arrivare allo scontro finale vittorioso, contro Annibale il condottiero romano e contro Napoleone il duca inglese. Mahan fa notare che lo storico inglese non evidenzia che ad entrambi i generali vincitori apparteneva il dominio del mare. Se nella seconda guerra punica non ci furono battaglie navali importanti ciò indicava una supremazia di Roma sul suo tradizionale rivale marittimo. Infatti per quale motivo Annibale avrebbe dovuto intraprendere una logorante marcia attraverso la Gallia e le Alpi per entrare in Italia, perdendo trentamila soldati veterani sui sessantamila con cui era partito? Evidentemente la sua flotta sulle coste spagnole non era forte abbastanza per competere con quella romana e proteggere un così grande trasporto di truppe in Italia.
Roma rispose a questa iniziativa con due distinte spedizioni navali che contavano insieme duecentoventi navi al comando dei due vecchi Scipioni e che portarono un esercito consolare in Spagna, sul fiume Ebro, e l'altro in Sicilia.
Con il primo, che occupava la regione dell'Ebro, i romani tagliavano le vie di comunicazione di Annibale dalla Spagna. Con il controllo della Sicilia venivano recisi i collegamenti marittimi con Cartagine. Annibale, che si era stabilito nell'Italia meridionale durante la sua campagna militare, si era alienato, col tempo, il favore delle popolazioni. Egli aveva necessità di rifornimenti e di rinforzi. Ma attraverso quali vie di comunicazione? Con Cartagine e la Spagna non era possibile visto che il potere marittimo romano controllava una porzione di mare a nord di una linea che andava da Tarragona a Marsala e da lì per la costa settentrionale della Sicilia attraverso lo stretto di Messina giú fino a Siracusa e quindi a Brindisi in Adriatico. Rimaneva la Macedonia ma Roma stabilí una base a Brindisi ed una squadra navale per controllare il basso Adriatico. La mancanza di una flotta da guerra da parte di Filippo V paralizzó tutti i suoi movimenti. Il potere marittimo romano tenne la Macedonia completamente fuori dalla guerra! Anche con la conquista di Taranto Annibale ebbe lo stesso problema in quanto la rocca dell'Acropoli resistette all'assedio rifornita via mare dalla flotta romana e lo scalo non potette essere usato dai cartaginesi per rifornire il suo generale.
Questo non escludeva scorrerie navali da parte cartaginese di supporto ad Annibale che comunque non permisero quelle comunicazioni continue e sicure che egli ricercó ma che non riuscí mai ad ottenere a causa del controllo che Roma esercitava sui mari interessati a quei traffici. La guerra durava da dieci anni quando Asdrubale entró in Italia da nord per cercare di ricongiungersi con suo fratello Annibale e sferrare, uniti i propri eserciti, il colpo decisivo alle legioni romane. Ma mentre Asdrubale attraversava la Gallia, Publio Scipione inviava dalla Spagna undici mila uomini via mare a sostegno dell'esercito romano dislocato a nord della penisola. Claudio Nerone, dopo aver intercettarono messaggeri di Asdrubale inviati al fratello, che indicavano il percorso che egli avrebbe seguito, distaccó 8000 dei suoi migliori soldati delle forze romane presenti al sud e le invió a nord, sfuggendo alla vigilanza di Annibale. Effettuato il ricongiungimento delle forze, i romani distrussero Asdrubale e le sue forze nella battaglia del Metauro con una schiacciante superioritá. Era la fine del sogno di Annibale di sconfiggere Roma. Cosa sono dunque il potere marittimo ed il dominio del mare ?
Mahan non dá alcuna definizione ma individua un insieme di elementi che contribuiscono, se ben usati dalla classe dirigente di uno stato, al loro raggiungimento; una flotta mercantile, una flotta militare e delle basi di appoggio, ovvero dei porti. La flotta mercantile, l'insieme delle navi che trasportano grandi quantitá di beni, nel modo ancor oggi piú veloce ed economico, genera ed amplifica la ricchezza del proprio paese. Affinché queste navi possano viaggiare su lunghi tragitti é necessario che abbiano degli scali intermedi in territori non ostili o amici. Una flotta militare ben organizzata sará necessaria pertanto a mantenere libere le vie di comunicazione per le proprie navi e negarle al naviglio del paese nemico. Una forza navale opportunamente dislocata puó creare deterrenza scoraggiando l'uso del mare da parte di altri paesi e rappresenta lo strumento per difendere una linea costiera o proiettare proprie forze militari sul campo abbreviando distanze e tempi. Nel momento in cui il commercio di Roma nel Mediterraneo occidentale cresce agli inizi del III secolo a.C. si arriva allo scontro per la supremazia sulla porzione di mare interessato da questi traffici. La I guerra punica porterá Roma a divenire una potenza marittima e sará l'intelligente uso del suo potere marittimo, nel corso della II guerra punica, a farle superare la dura prova contro Annibale. Nonostante tutti questi insegnamenti non venne creata una flotta permanente.
Nel libro “The Roman Imperial Navy”, pubblicato nel 1941, Chester G. Starr apre la sua interessante disamina evidenziando che la pace sul mare poggiava su un disarmo navale imposto da Roma agli inizi del II secolo a.C. e rotta in successione dall'invasione della Grecia da parte di Mitridate, dalla pirateria e dalle guerre civili. É la prima guerra Mitridatica (88-84 a.C.) l'evento che segna se non gli inizi della marina imperiale Romana certamente quelli del suo primo nucleo permanente. Nell' 84 a.C., con la conclusione della pace con Mitridate, Silla fece allestire una flotta di circa cento navi militari per la difesa dell'Asia Minore, a spese delle città marittime alleate. Esse saranno tuttavia insufficienti a combattere la pirateria, della Cilicia in particolare, che diverrà in pochi decenni una piaga che infesterà tutto il Mediterraneo. L'improvvisa apparizione di una grande flotta romana nel 67 a.C., al comando di Pompeo, che verrà a capo del problema, si spiega con l'integrazione di forze navali romane alle preesistenti alleate già operanti nel settore orientale del Mediterraneo. Nel 62 a.C. Pompeo ottenne, al costo di quattro milioni e trecentomila sesterzi, che una flotta permanente pattugliasse il Mar Tirreno e l'Adriatico. Nel mar Egeo, nello stesso anno, il governatore dell'Asia Flacco esigeva fondi per la manutenzione di una squadra di navi militari che pattugliavano, divise in due flottiglie, a nord e sud di Efeso. Guerre Mitridatiche e pirateria tornavano a mostrare l'importanza del potere marittimo, dimenticato sin dalle guerre Puniche e la necessità di avere forze navali stabili. Pompeo fece un uso abile del potere marittimo e quando lasciò Roma all'inizio della guerra civile contro Cesare contava ad Oriente su una flotta di trecento navi. Nel 48 a.C. la flotta pompeiana arrivò ad insediare, in Adriatico, i rinforzi che Cesare attendeva a Dyrrachium. Ma se Pompeo aveva fiducia nel potere marittimo Cesare aveva fiducia nel mare. Il mar Adriatico d'inverno limitò l'azione della flotta di Pompeo che fu vicina al successo con l'interdizione dello sbarco delle forze in supporto di Cesare.
Nel 43 a.C., dopo la morte di Cesare, il Senato affidò le flotti della Repubblica (un tempo le navi di Cesare e Pompeo) a Sesto Pompeo per rafforzarlo come contrappeso ad Ottaviano ed Antonio. Poiché la Sicilia e la Sardegna erano nelle sue mani, con queste navi divenne, nei due anni che seguirono, il signore del Mediterraneo Occidentale attaccando le coste della penisola ed arrivando ad affamare Roma tagliandole i vitali rifornimenti di grano provenienti dall'Egitto. Ottaviano, il futuro Augusto, a Roma fece grande tesoro di questa esperienza; vide la sregolatezza del popolo innanzi alle scorte di grano che si esauriscono, la devastazione portata da Sesto con gli attacchi dal mare e la difficoltà nel creare una flotta per eliminare queste minacce al suo controllo dell'Italia. Gli accordi di Miseno del 39 a.C. tra Antonio, Sesto ed Ottaviano permetteranno un periodo di pace a quest'ultimo per l'allestimento di una grande flotta nel 38 a.C. ed una seconda, di 400 navi, nel 37 a.C. dopo che la prima era andata distrutta per delle tempeste ed a causa di una sconfitta. L'amico e consigliere di Ottaviano, Marco Vipsiano Agrippa fece realizzare per l'occasione il Portus Iulius nel cratere del lago Averno per poter addestrare al sicuro rematori e marinai. Nella primavera del 36 a.C. cominciò la campagna contro Sesto Pompeo attaccato in Sicilia ad Ovest da forze di Lepido provenienti dall'Africa, a Nord da forze navali di Agrippa e ad Est da forze navali congiunte di Ottaviano ed Antonio provenienti dall'Adriatico per l'immissione di contingenti sull'isola. La sconfitta navale di Sesto Pompeo a Nauloco, il 3 settembre del 36 a.C. segnó la sua fine. La nuova arma, l'arpagone, montato sulle navi di Agrippa aveva fatto la differenza nello scontro. Lo stesso giorno del 31 a.C., con la battaglia navale di Azio, Ottaviano diventerà il signore unico. Ottaviano probabilmente aveva in mente il pensiero di una marina permanente se non distrusse le trecento navi di Antonio che a lui si arresero e che unì alle sue quattrocento unità. Con questa decisione inizia la storia della marina imperiale romana. Le prime vennero stanziate a Forum Iulii, un porto realizzato vicino alla foce del Rodano. Concepito per azioni navali contro Sesto e per l'invio di truppe e supporto logistico nelle Gallie risalendo il grande fiume. Prima del 22 a.C. queste forze verranno ridislocate e fuse con la flotta di Miseno. Nel 69 d.C. il porto di Forum Iulii scomparirà a causa di problemi legati all'insabbiamento dei suoi bassi fondali.
Compito della marina sarebbe stato non di combattere delle battaglie ma di renderle irrealizzabili con il controllo del mare. Lo studio dello storico Chester G. Starr si basa sulle ottocento iscrizioni su pietra fatte realizzare dai membri delle varie flotte presso le aree in cui le navi militari erano di base o temporaneamente stanziate e su pochissimi riferimenti della letteratura dei primi secoli dell'età imperiale. A questo, a mio modesto parere, va aggiunto una forma mentis dell'autore che sulla scia di quanto indicato da Mahan analizza gli eventi con la prospettiva di chi guarda dal mare e considera gli effetti dell' utilizzo del potere marittimo come un argomento intimamente collegato con la politica e la storia generale dell'impero. Senza questa “predisposizione” difficilmente si riuscirebbe a concepire uno studio in tal senso. Questa attenzione all'esercizio del potere marittimo mi sembra ancora più interessante se si considera l'anno in cui l'opera di Starr viene pubblicata, il 1941. Gli Stati Uniti non sono ancora la grande potenza navale che diventeranno nel corso degli anni seguenti dopo l'ingresso nella II guerra mondiale. Il dominio di tutti i mari del mondo, conquistato dagli americani a costo di immani sacrifici umani, particolarmente nel Pacifico, costituirà la condizione iniziale per arrivare alla vittoria su tutti i fronti terrestri. Grazie ad un imponente apparato industriale ma guardando il mare nei termini sopra richiamati.
Torniamo ora ad Ottaviano. Egli aveva appreso e toccato con mano che chi controllava il mare poteva affamare Roma e che un popolo affamato era difficilmente gestibile. Sconfitto Sesto Pompeo, Antonio e Cleopatra avevano ancora le mani sul granaio dell'impero e la flotta egizia doveva essere sconfitta e posta sotto il controllo di chi deteneva il potere nell'Urbe. Le basi della sua pax romana poggiavano sul controllo del Mediterraneo, sulla conseguente libera navigazione e sulla certa capacità di poter portare la forza militare delle legioni ovunque. In altre parole sull'esercizio del potere marittimo. Classis Misenensis e Classis Ravennatis nacquero con questo chiaro obiettivo strategico di Ottaviano negli anni successivi alla vittoria di Azio. È impossibile fissare con certezza la data della loro costituzione per indifferenza degli storici del tempo nel soggetto navale.
Classis Misenensis
La flotta posta nel nuovo porto militare di Miseno, in un sito al riparo da tutti i venti, poiché Portus Iulius si era insabbiato e comunque sarebbe stato poco adatto per le sue dimensioni, per secoli funzionò come quartier generale della flotta. Posta vicino a Roma e agli ordini dell'Imperatore i suoi principali scopi erano il dominio del Tirreno e la vigilanza sulla rotta finale delle navi granarie provenienti da Egitto, Africa e Sicilia. Da informazioni del 68-69 d.C. si ha contezza della presenza di circa diecimila marinai a Miseno, sufficienti per armare oltre 50 triremi. La flotta poteva contare anche su altri porti strategici sul litorale tirrenico per intervenire in sporadici episodi di pirateria in Sardegna e Corsica. Alcune triremi vennero dislocate ad Aleia, capoluogo dell' isola di Corsica, attestate da due iscrizione navali trovate sul posto. Questa serie di infrastrutture portuali fu potenziata dagli imperatori romani che succedettero ad Augusto. Claudio fece realizzare il Portus Ostiae, in uso fino al III secolo, come punto d'arrivo delle navi granarie e per favorire il trasbordo su navi fluviali, ma, non meno importante, come scalo di partenza dello stesso imperatore, dei senatori e degli equites nei loro viaggi verso le province dell'impero. Centumcellae, l'odierna Civitavecchia, venne realizzata da Traiano nel 107-108 d.C..
Classis Ravennatis
La flotta ravennate venne sistemata tra il 25-23 a.C. in una laguna sull'Adriatico fortificata con moli e dotata di accasermamenti ed un faro. Era collegata con un canale navigabile al Pó ed a Ravenna. La Chiesa di San Apollinare in Classe richiama l'antica Classis Ravennatis ed oggi é presente un interessante museo archeologico laddove sorgeva questo porto militare romano. Questo porto é splendidamente rappresentato nei mosaici della Basilica di Sant'Apollinare Nuovo a Ravenna. Ancora funzionante nel VI secolo d.C.. La scelta di Augusto era significativamente strategica in quanto il porto era protetto dalle paludi, era posto nei pressi di una foresta da cui ricavare il legname per le costruzioni navali ed era ben raccordato con lo snodo viario delle vie Flaminia ed Emilia. La sua posizione consentiva di rinforzare la linea difensiva a protezione dell'Italia settentrionale che correva attraverso il fiume Pó fino a Piacenza. Il porto permetteva il controllo ravvicinato della costa dalmata e costituiva un eccellente base di supporto logistico per la guerra nell'entroterra orientale dell'Adriatico, l'Illirico. Gli scali per le navi ravennate erano Aquileia e Salona (oggi Spalato). Alcune navi della flotta erano dislocate a Brindisi per trasporto dignitari a Dyrrhachium. Le sfere di responsabilità delle due flotte non erano limitate ai due opposti mari della penisola italica poiché operarono congiuntamente sia in oriente che in occidente, con le navi ravennate in assistenza a quelle di Miseno. Sono state trovate infatti iscrizioni delle prime al Pireo e la tomba di un “classista” in Spagna. Interessante é scoprire che il piú grande distaccamento delle due flotte era a Roma, pur non essendoci nessuna nave militare. I marinai presenti nell'Urbe con l'ascesa di Claudio nel 41 d.C. erano presenti al Castra Pretoria. Con i Flavi verrano sistemati in apposito “Castra” fatto realizzare a sud-est del Colosseo, sull'Esquilino, e registrato nei cataloghi regionari del IV secolo d.C.. Il loro impiego andava dal funzionamento della complessa macchina burocratica imperiale, per quanto atteneva alla marina, ai servizi propri nei giochi navali, al supporto ai vigiles. Ma chi era a capo delle flotte, chi erano gli ufficiali in comando, da chi erano costituiti gli equipaggi e che genere di navi costituiva l'ossatura della flotta imperiale?
Posti di comando
La marina, come l'esercito, era affidata a dei prefetti della flotta che prendevano ordini direttamente dallo stesso imperatore e verso cui erano responsabili. Il precedente degli ammiragli a capo della flotta, iniziata con Marco Vipsiano Agrippa, membro della classe degli equestri, rimase ininterrotto. L'unico senatore ammiraglio compare nella storia dell'impero nel 214-217 d.C. , scelto da Caracalla per comandare una campagna navale nell'oriente. Presumibilmente i senatori, che rappresentavano l'antica aristocrazia terriera, non amarono mai il mare e di conseguenza la marina. Negli anni dal 41 al 69 d.C. si ha notizia di tre prefetti liberti. La lunga pace di cinquanta anni nel Mediterraneo portó infatti Claudio a rivedere tale incarico considerandolo come un ruolo semi-amministrativo piuttosto che militare. Dal punto di vista della loro remunerazione i prefetti delle flotte italiane si collocarono in poco tempo, all'interno della burocrazia imperiale, al livello dei ducenari, coloro il cui stipendio annuo era di duecentomila sesterzi. Tale posizione veniva raggiunta dai più abili tra gli equites dopo lunghi e vari anni di servizio nello stato imperiale. Dopo una lunga e variegata carriera Plinio il vecchio venne nominato praefectus classis Misenis da Vespasiano verso la fine degli anni 70 d.C.. Il loro mandato durava dai quattro ai cinque anni, come attestato dallo studio delle iscrizioni del II secolo d.C.. Agli ordini del praefectus classis erano posti i navarchi, assimilabili al grado di ammiraglio e che comandavano una squadra di sessanta navi. Erano qualificati e capaci marinai greci che ricevevano la cittadinanza romana mentre erano in servizio. Da loro dipendevano i trierarchi, i comandanti delle navi. Questi ultimi provenivano dalle popolazioni costiere. Si ha notizia di due navarchi provenienti dalla Dalmazia e di molti altri di lingua greca provenienti dalle coste orientali dell'impero. Il loro servizio durava ventisei anni.
Gli equipaggi.
Gli equipaggi militari romani erano una delle piú complesse organizzazioni delle forze romane in quanto espletavano funzioni militari e navali. Ogni equipaggio formava una centuria con i suoi classici. Faceva parte del loro addestramento l'uso delle armi. Alcuni membri erano preparati a saper compiere arrembaggi e combattere contro i pirati. Le attivitá navali erano legate alle tre condizioni indispensabili per il funzionamento della nave; direzione, moto e manutenzione. Ognuna con un proprio ufficiale responsabile a capo. Il gubernator supervisionava i movimenti dei due addetti ai timoni sterzanti e la navigazione in generale. Si evince dai loro elaborati monumenti ritrovati che erano ben pagati e che prendevano in prestito cognomi greci. Il celeusta o pausarius controllava il lavoro dei rematori dando loro il ritmo con un ritornello a cui forse questi ultimi rispondevano con un canto marinaresco. Sulle unitá maggiori, a capo del personale del trierarca, vi era un beneficiarius, l'equivalente di un tribuno equestre nella legione, ai cui ordini un secutor rilanciava gli ordini verso il basso ed organizzava il lavoro dello scriba, che redigeva rapporti per l'amministrazione centrale, e del librarius, che si occupava degli aspetti finanziari. Il solco tra centurioni e soldati, grande nella legione, appare meno profondo sulle navi dove gubernatores ed altri ufficiali erano parte dei centurioni. I marinai erano costituiti inizialmente da peregrini poiché i cittadini romani ed i latini in genere avevano una innata antipatia nei confronti del mare. Gli schiavi non erano arruolati nelle fila dell'esercito di Roma e di conseguenza non lo furono nella marina imperiale. Solo nel 37 a.C. Ottaviano dovette ricorrere a ventimila schiavi per armare le navi che stava allestendo contro la flotta di Sesto, ma li rese tutti liberi ancor prima di arruolarli. A quindici anni ci si poteva arruolare nella marina imperiale con la prospettiva di essere congedati dopo ventisei anni di servizio. Il personale reclutato per le due flotte italiane proveniva in massima parte dalle aree delle due basi principali: Miseno e Ravenna. Grazie alle sorgenti epigrafiche si é anche potuto stabilire che tra la fine del I e gli inizi del III secolo a Ravenna vi era una una grande presenza di marinai provenienti dai Balcani e che questa era minore a Miseno dove invece una larga parte proveniva dall'oriente ellenizzato.
Il naviglio.
La nave più diffusa nella marina imperiale di Roma era la trireme seguita dalla quadrirema, in numero minore la quinquereme. Erano navi costruite attingendo ai collaudati standards delle navi militari ellenistiche e della Repubblica ed adattate alle esigenze delle tattiche romane di abbordaggio. Un particolare tipo di imbarcazione impiegata in piccoli numeri era la veloce liburna, una bireme usata originariamente dai pirati dalmati della tribù dei Liburni. Non possiamo parlare di navi comode e dalla buona tenuta del mare visto la loro massima lunghezza di sessantasei metri e l'altezza dal mare delle loro murate di tre metri. In inverno il naviglio militare non era impiegato. A bordo gli spazi erano minimi. Su una quinquereme, nel regno di Caligola, trovavano posto quattrocento rematori. Sulla più diffusa trireme, su un equipaggio di duecento marinai, centocinquanta erano rematori. Il lavoro dei rematori era spossante nei lunghi viaggi e per aumentare la lenta andatura, vento permettendo, era issato un albero centrale a vela quadra in aggiunta alla piccola vela di prora. Nella flotta di Miseno era presente un' esareme probabilmente ammiraglia della flotta imperiale. Sulle prore erano disegnati gli occhi mistici che si rifacevano alle antiche navi mentre delle lettere richiamavano i nomi dell'unità; grandi fiumi, eroi e siti di battaglie greche, virtù. Sulla poppa trovava posto la tutela,la divinità patrona della nave, e talvolta la cabina del trierarca.
Gli squadroni provinciali del Mediterraneo.
Le necessità dell'impero richiedevano degli squadroni indipendenti in Egitto, Siria e Mauritania. Ben oltre l'immediata sfera d'influenza delle flotte italiane. Queste flottiglie erano poste sotto il comando del praefectus classis che rispondeva direttamente al locale governatore, il comandante in capo delle forze militari dislocate nel suo territorio. La trireme era l'unità più largamente impiegata insieme alla liburnia. Queste flottiglie non erano state concepite per essere impiegate in vere e proprie guerre navali. Il loro compito era piuttosto quello della deterrenza. La classis alexandrina, composta da equipaggi egiziani, viene nominata per la prima volta durante il regno di Nerone ma la sua nascita deve essere collocata con la riorganizzazione dell'Egitto compiuta da Augusto nel 30 a.C.. Suo compito principale era quello della sorveglianza della rotta iniziale del grano destinato a Roma per prevenire o impedire attacchi portati da un usurpatore. In caso di particolari crisi poteva essere impiegata per integrare le unità fluviali operanti nell'alto Nilo per il trasporto di distaccamenti militari egiziani e contro i banditi del deserto. Una grande emergenza fu la rivolta generale degli Ebrei dal 115 al 117 d.C.. Traiano inviò rinforzi militari e navali al comando di Q. Marcio Turbo per soffocare la ribellione in Egitto e Cirenaica. Tutte le forze navali e fluviali vennero posto sotto il comando di un singolo prefetto. Per quanto concerne la classis syriaca vi sono evidenze databili della sua esistenza sotto il regno di Adriano. I suoi compiti principali erano il controllo della costa della Siria e l'impiego sulle rotte con l'Occidente per garantire comunicazioni e trasporti di dignitari. Il suo naturale porto sarà stato Seleucia, il maggiore dell'area, la cui importanza risalta dalla cura con cui da Augusto a Valentiniano venne continuamente migliorato. Uno degli imperatori Giulio-Claudi rese l'Oronte navigabile da Seleucia alla non molto distante Antiochia. Dopo l'annessione della Mauritania, durante il regno di Caligola, nel 40 d.C., si hanno tracce di unitá delle flottiglie dell'Egitto e della Siria distaccate nel porto di Cesarea Mauritania per oltre un secolo. La presenza di tribù locali dedite alla pirateria richiedeva la presenza di questa forza navale romana. Durante gli anni settanta del II secolo d.C. le tribù dei Mori, battute alcuni decenni prima dall'intervento di truppe romane della Spagna, crearono disturbi ai traffici marittimi tali da richiedere l'intervento delle flotte italiane. Agli inizi del III secolo si rese necessario la creazione di una classis nova libyca di cui si perdono le tracce cinquanta anni dopo. Ancora una volta emerge chiara, a mio modesto parere, l'importanza del potere marittimo che Augusto seppe declinare in tutte le sfaccettature adattandole alle specifiche esigenze dei vari teatri operativi. Una piena coscienza del potere marittimo, probabilmente, che viene meno due secoli e mezzo dopo o la cui applicazione globale, come realizzata dal primo imperatore, viene lentamente ed inesorabilmente trascurata. Mi sento di poter affermare che Augusto divenne prima signore del mare e assicuratasi la pace nel Mediterraneo partì alla conquista di altri territori.
Potere navale sulle frontiere del nord.
Flotte romane vennero create sul Reno e sul Danubio per assicurarsi il controllo navale dei fiumi e proteggere i confini dell'impero ma allo stesso tempo per poter appoggiare e sostenere incursioni ed invasioni romane oltre le proprie rive. Con l'espansione verso est e verso ovest di questi fiumi durante i regni di Claudio e Nerone il Mar Nero ed il Canale della Manica finiranno sotto lo stretto controllo di Roma con la creazione delle rispettive flotte, classis pontica e classis britannica. La classis pontica venne creata nel 64 d.C. per avere un maggior controllo del Mar Nero e del Bosforo. Trebisonda, la sua base, giocava un ruolo strategico di importanza vitale per le mire che Roma aveva verso l'Armenia e garantì la pace in quel bacino di mare per i successivi centocinquanta anni insieme al controllo che dall'altro versante garantiva la classis moesica. La classis britannica, la cui base era il porto di Gesoriacum (oggi Boulogne-sur-Mer) nasceva dall'esperienza della flotta creata da Cesare e di cui scrive nei suoi Commentaries. Il porto militare venne realizzato da Caligola ma fu sotto il regno di Claudio che da qui partirono nel 43 d.C. le navi che portarono agli sbarchi sulle coste a sud-est del Kent ed alla trionfale campagna dei generali romani. Il compito di questa flotta sarà principalmente il trasporto di uomini e materiali dal continente europeo alla Britannia. Rutupiae (oggi Richborough) venne realizzata come stazione navale per ricevere il traffico sull'isola. Da qui strade romane portavano a Canterbury e procedevano per Londra. Il praefectus della classis britannica dipendeva dal legato dell'isola e gli equipaggi erano costituiti da marinai provenienti dalla Tracia, dalla Pannonia e dall'Africa. Dal 293 al 296 d.C. questa flotta divenne, unica volta nella storia dell'Impero Romano, la base del potere dell'usurpatore Alletto nella Britannia, finché con un'altra flotta realizzata da Costantino presso Gesoriacum, nello stesso periodo, il Cesare d'occidente Costanzo Cloro (padre di Costantino) riprese il controllo dell'isola sconfiggendo l'avversario. Il Danubio divenne sotto Augusto una nuova linea di frontiera dell'impero dopo le conquiste nei Balcani. Sulle sue rive romane vennero realizzate, come sistema difensivo avanzato, una serie di presidi militari messi velocemente in comunicazione tra di loro con l'ausilio di una serie di flottiglie lungo tutto il suo corso e quello dei suoi maggiori affluenti, la Sava e la Drava La classis moesica, posta a servizio nella parte bassa del Danubio, garantiva anche lo stretto controllo del litorale settentrionale del Mar Nero. La classis pannonica operava nella parte alta del grande fiume. Dopo il 69 d.C., l'anno dei quattro imperatori, entrambe le flottiglie ricevettero il titolo di flavia in commemorazione del loro servizio, quando il fiume venne privato delle legioni poste a sua difesa e agli ordini del generale Antonio Primo marciarono in Italia, in appoggio a Vespasiano. La loro importanza strategia divenne fondamentale durante le guerre daciche combattute da Traiano dal 101 al 106 d.C. quando le forze navali fluviali vennero utilizzate come ponti di barche per l'avanzata delle legioni nei territori nemici da conquistare. Dopo la conquista della Dacia gli imperatori successivi, Adriano e Antonio Pio, portarono il regno del Bosforo Cimmerio ad essere soggetto a Roma, chiaro segno di un indiscusso dominio romano di quel mare.
Noviodunum era la principale base della flottiglia della Moesia (oggi nei pressi di Isaccea, Romania). Taurunum, a cinque km a nord della congiunzione della Sava con il Danubio, era il porto militare della flottiglia della Pannonia (oggi Zemun, a nord di Belgrado in Serbia). La classis germanica, di cui si hanno piú informazioni storiche e geografiche, operò sul Reno ed i suoi porti militari sorpassarono di gran lunga il numero delle altre flottiglie minori. Augusto puntò alla conquista dei territori che andavano fino all'Elba e il suo generale Druso Maggiore creò a questo scopo la flotta germanica. Druso fece scavare un canale navigabile nel 12 a.C. per congiungere il Reno al Lacus Flevus (oggi Ijsselmeer in Olanda) e trasportarvi le sue forze militari per sottomettere le tribù della Frisia. Navigando verso est raggiunse le terre dei Cauci, confinanti con la Frisia, divenendo il primo generale romano a navigare nel Mare del Nord. Nel 4 d.C. Tiberio riprese la conquista della Germania e la classis germanica raggiunse l'estuario dell'Elba per rifornire le legioni. Le rivolte in Pannonia ed il disastro di Varo a Teutoburgo nel 9 d.C. fermarono questi piani di conquista. Nell'inverno del 15-16 d.C. Germanico, il figlio di Druso Maggiore e figlio adottivo di Tiberio, fece allestire una flotta sul Reno di mille navi per imbarcarvi otto legioni, truppe di ausiliari e scorte. Attraverso la fossa drusianae la sua forza d'invasione raggiunse il Mare del Nord raggiungendo le rive del fiume Amise (oggi Ems) nei pressi della foresta di Teutoburgo. Nonostante diverse battaglie vinte la campagna militare non riportò i territori delle varie tribú germaniche tra Reno ed Elba sotto il dominio di Roma. Nel viaggio di ritorno una tempesta colpì l'imponente flotta e la spedizione terminò in un disastro. Tiberio richiamò suo figlio e l'offensiva fu chiusa. La flotta germanica venne ridotta nelle sue dimensioni e riorganizzata in funzione difensiva sul Reno. Il suo quartier generale venne posto ad Ara Urbiorum che in seguito divenne Colonia Agrippina (oggi Colonia). A capo della classis germanica era posto un praefectus centenarius dipendente dall'autorità del governatore della provincia. Se alle origini i marinai provenivano dal Mediterraneo con l'assimilazione della civiltà romana da parte delle popolazioni locali verrano arruolati germanici tra gli equipaggi nel corso del III secolo d.C.. La presenza di questa flottiglia impedì la navigazione del Reno ai germanici e vi sono indicazioni di costruzioni di naviglio adibito a questi compiti fino al IV secolo.
Conclusioni
“The Silent Service” é l'appellativo usato nel Regno Unito per riferirsi alla Royal Navy ed alla conclusione di questa descrizione ritengo di poterne applicare la denominazione anche alla marina imperiale romana. Augusto impostò un' articolata forza navale permanente nel Mediterraneo che non combatté per due secoli nessuna seria battaglia e le cui flottiglie organizzate sul Danubio, sul Reno, sulla Manica e sul Mar Nero rappresentarono un raffinato ed efficace esercizio del potere marittimo che mai si era visto prima come espressione di un'unica autorità statale in una così vasta area. L'estensione dell'impero romano raggiunse i cinque milioni di chilometri quadrati che diventano sette milioni e mezzo considerando il solo Mediterraneo con un rapporto terra:mare di 2:1. É necessario, a mio modesto di vedere, dedicare una riflessione a questo aspetto. L' uso ed il controllo del mare (e dei grandi corsi d'acqua) é stato il più delle volte un servizio “silenzioso” ma funzionale all'espansione, ai traffici commerciali, alla difesa ed al funzionamento dell'Impero. Tanto “silenzioso” da non essere stato molto trattato dagli autori storici del tempo come lamenta Starr. L'ambiente navale militare doveva essere molto duro, considerando la tipologia delle imbarcazioni e la tipologia del servizio e non aveva i grandi numeri delle legioni e la visibilità delle stesse. Le navi si vedono quando sono in porto, quando prendono il largo solo il loro equipaggio e le autorità conoscono le missioni che compiono, talvolta i primi non conoscendone le finalità ultime. Probabilmente a Roma, la pace di cui si scriveva, aveva fatto dimenticare, a chi non strettamente legato alla vita del mare, l'importanza di continue risorse da investire in quell' organizzazione che aveva largamente contribuito a realizzarla. Quando alla fine del III secolo appariranno flotte ostili la marina imperiale verrà spazzata via perché diventata inadeguata alla sua missione e l'atteggiamento dell'Impero regredito alla politica della Repubblica di allestire delle flotte per fronteggiare le emergenze. Starr spiega che con Vespasiano la marina aveva raggiunto il suo apogeo e venne ricolmata di onori. I decenni seguenti di pace e la radicata indifferenza romana al mare distruggeranno lo spirito di prontezza navale nonostante la tradizione mantenne viva la marina. Si ha notizia di dieci squadroni provinciali esistenti nel 230 d.C. che scendono inspiegabilmente a tre nel 285 d.C. quando Diocleziano diviene imperatore a Nicomedia. Se la presenza di flotte militari prevenne o scoraggiò l'iniziativa nemica la sua piccola consistenza ottenne l'esatto opposto. Ne conseguì il negativo impatto sui traffici commerciali per il rinascere della pirateria. La lenta e progressiva perdita della sicurezza sul mare avrebbe finito per impattare sui commerci verso l'Italia e sul ridimensionamento della sua ricchezza. Nel 324 d.C. l'uso delle forze navali nella campagna di Costantino contro Licinio portò alla fine della marina imperiale come una forza effettiva. Mentre in seguito a Costantinopoli verrà mantenuta una forza navale per mantenere il controllo del Mediterraneo orientale attingendo alla tradizionale riserva di reclutamento dell'Egeo, l'occidente, cui mancava un bacino di arruolamento tradizionale, abbandonerà il mare consegnandolo ai Vandali nel V secolo.
Le flotte di Miseno e Ravenna lentamente scompariranno. È mia opinione che sul mare, più che sulla terra, la pax romana nacque e fu effettiva per oltre due secoli se si considera l'assenza della pirateria nel Mediterraneo, non documentata fino agli inizi del III secolo, il continuo approvvigionamento di grano che sfamava l'enorme popolazione di Roma e l'enorme vantaggio di linee commerciali e di comunicazione interne del Mare Nostrum che resero Roma prospera. A tutt'oggi é davvero poco concepibile questo aspetto perché non godiamo di una fascia costiera mediterranea completamente pacificata. Non rientra nel nostro comune ordine d'idee guardare a questo importante bacino come poteva fare un ricco commerciante di Roma, un funzionario imperiale, l'equipaggio di una nave militare o mercantile che dopo un lungo viaggio avrebbe trovato in un qualunque porto d'arrivo le stesse istituzoni, le stesse leggi vigenti a Roma ed avrebbe potuto usare la sua lingua non temendo di non essere capito. Basta guardare alla Siria, alla Libia, al Libano ed alle coste della Striscia di Gaza per rendersi conto di quanto territori apparentemente lontani non lo sono così tanto da non avere ripercussioni politiche ed economiche sia sull'Italia che sull'intera Europa. Per i romani le coste di tutto il Mediterraneo, da Augusto e per un lungo tempo, saranno approdi sicuri che permetteranno la libera circolazione di uomini, merci, cultura e tradizioni non solo grazie alla presenza sul territorio delle legioni.
Francesco Mancini