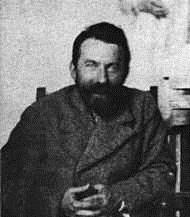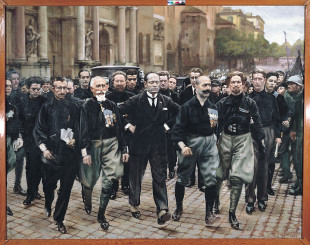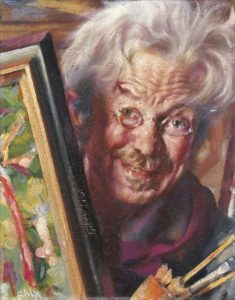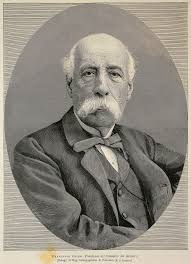![]()
La storia della religione romana costituisce un tema al centro dell’interesse della Scuola di Roma, a partire dal suo fondatore, Raffaele Pettazzoni. R. Pettazzoni possedeva una solida formazione classicista (1) e già dai suoi primi studi manifestò un’attenzione nei confronti del mondo romano: nella relazione Le superstizioni, presentata nel 1911 al I° Congresso di Etnografia Italiana (2), lo studioso attraverso il rimando al mondo antico, greco e romano, respinse l’ipotesi allora prevalente che vedeva nella superstizione niente altro c![]() he un survival, per avvalorare al contrario l’idea che essa costituisse a pieno titolo in origine «un fatto della religione» (3). A tale scopo, Pettazzoni riprese l’etimologia formulata in quegli anni da Walter F. Otto, il quale associava il latino superstitio al greco ekstasis, come termini indicanti un tipo di esperienze caratterizzato dal distacco dal corpo (4) e dal contatto non-mediato con una dimensione estranea e superiore a quella dell’esistenza normale. In tale prospettiva, il valore di survival, lungi dall’essere intrinseco, sarebbe stato piuttosto, per Pettazzoni, il risultato del rifiuto di tali esperienze, rifiuto formulato dai Romani e dai Greci, prima ancora che dal Cristianesimo, nei confronti di quanto si contrapponeva ai culti civici riconosciuti dallo Stato (5). Al di là dei pregiudizi scientifici che emergono nella successiva classificazione morfologica delle superstizioni, pienamente giustificati in uno studioso ancora in formazione e che peraltro non poteva avvalersi dell’intervento orientativo di alcun maestro (6), il contributo del 1911 ha un suo interesse per la storia degli studi, in quanto testimonia la lucida contrapposizione che Pettazzoni opera tra una dimensione individuale ed una dimensione collettiva del fenomeno religioso, distinguendone gli esiti sulla base del referente (7). Se in questo primo lavoro l’interesse per la religione romana si concentra in pochi rapidi accenni, esso inizia a manifestarsi in maniera compiuta a partire dalla relazione che Pettazzoni propose alla discussione nel I° Congresso Nazionale di Studi Romani (1929): Per lo studio della religione dei Romani (8).
he un survival, per avvalorare al contrario l’idea che essa costituisse a pieno titolo in origine «un fatto della religione» (3). A tale scopo, Pettazzoni riprese l’etimologia formulata in quegli anni da Walter F. Otto, il quale associava il latino superstitio al greco ekstasis, come termini indicanti un tipo di esperienze caratterizzato dal distacco dal corpo (4) e dal contatto non-mediato con una dimensione estranea e superiore a quella dell’esistenza normale. In tale prospettiva, il valore di survival, lungi dall’essere intrinseco, sarebbe stato piuttosto, per Pettazzoni, il risultato del rifiuto di tali esperienze, rifiuto formulato dai Romani e dai Greci, prima ancora che dal Cristianesimo, nei confronti di quanto si contrapponeva ai culti civici riconosciuti dallo Stato (5). Al di là dei pregiudizi scientifici che emergono nella successiva classificazione morfologica delle superstizioni, pienamente giustificati in uno studioso ancora in formazione e che peraltro non poteva avvalersi dell’intervento orientativo di alcun maestro (6), il contributo del 1911 ha un suo interesse per la storia degli studi, in quanto testimonia la lucida contrapposizione che Pettazzoni opera tra una dimensione individuale ed una dimensione collettiva del fenomeno religioso, distinguendone gli esiti sulla base del referente (7). Se in questo primo lavoro l’interesse per la religione romana si concentra in pochi rapidi accenni, esso inizia a manifestarsi in maniera compiuta a partire dalla relazione che Pettazzoni propose alla discussione nel I° Congresso Nazionale di Studi Romani (1929): Per lo studio della religione dei Romani (8).
Alla presunta «povertà di esperienze emozionali», alla palese assenza di un apparato mitologico originale, alla rigida fissità del formulario rituale, alla minuziosità procedurale degli atti cultuali, indicate dagli studiosi come segnali di un non completo assetto politeistico e quindi come un limite intrinseco della religione di Roma, Pettazzoni contrappone «le vibrazioni dell’anima religiosa romana» che si manifestarono, ad es., negli anni drammatici e gloriosi della Seconda Guerra Punica: «allora l’anima romana cercò, implorò, scongiurò disperatamente l’aiuto divino, escogitò nuove forme di adorazione per ottenerlo» (9). Per quanto riguarda l’aspetto metodologico, Pettazzoni, in quella sede, pur consapevole delle distorsioni insite nel ricorso indiscriminato alla comparazione, esprime il suo vivo apprezzamento nei confronti di quella che era apparsa come la più notevole conquista scientifica dell’epoca, ossia l’applicabilità ai popoli dell’antichità classica di paradigmi ermeneutici desunti dalle culture cd. primitive e riconosce alla scuola antropologica il merito di aver allargato l’approccio comparativo anche a settori fino ad allora impermiabilmente chiusi nel loro tecnicismo antiquario-filologico (10). In particolare, lo studioso appare interessato alla valorizzazione dell’elemento magico - presente soprattutto nella fase arcaica della religione romana- operata dalla scuola antropologica (11). Il limite di tale approccio, piuttosto che nel possibile arbitrio ermeneutico, veniva da Pettazzoni individuato nel carattere astorico della ricerca antropologica, poco![]() o niente interessata a tracciare e rintracciare le linee delle dinamiche culturali e tutta volta al rilevamento delle eventuali sopravvivenze. Ciò che al contrario Pettazzoni intendeva sottolineare era la necessità di introdurre anche nella religione romana, attraverso l’antropologia comparativa, il «concetto di svolgimento» (12), criterio individuante e tratto distintivo del metodo storicista, che non mira a formulare astratte generalizzazioni, ma tende a ricostruire dietro ogni evento il processo dinamico che lo ha determinato (13). Se ogni phainómenon, secondo la nota formula pettazzoniana, è un genómenon (14), si può affermare allora che la storia della religione romana coincide, per Pettazzoni, con la storia delle successive trasformazioni dettate dall’esigenza di adattare le espressioni del culto di volta in volta alle mutate condizioni della cosa pubblica (15); soprattutto nel periodo post-repubblicano, essa è, per Pettazzoni, la storia delle riforme attuate «sul vecchio tronco della religione romana tradizionale e nazionale per adeguarla alle nuove esigenze del nuovo stato super-nazionale che è l’impero» (16). L’adozione del Cristianesimo come religione di stato appare dunque allo studioso solo come l’ultimo a livello cronologico di questi interventi di riforma: esso fu bensì quello definitivo, ma non comportò a suo giudizio una frattura sul piano storico. Dalla religione antica di Roma alla storia religiosa moderna, Pettazzoni vedeva i segni di una continuità che suggeriva (ma Pettazzoni scrive: «impone») lo studio della religione romana non solo come momento di un processo unitario, ma anche come strumento di allargamento della coscienza storica e come «speciale interesse nazionale» (17).
o niente interessata a tracciare e rintracciare le linee delle dinamiche culturali e tutta volta al rilevamento delle eventuali sopravvivenze. Ciò che al contrario Pettazzoni intendeva sottolineare era la necessità di introdurre anche nella religione romana, attraverso l’antropologia comparativa, il «concetto di svolgimento» (12), criterio individuante e tratto distintivo del metodo storicista, che non mira a formulare astratte generalizzazioni, ma tende a ricostruire dietro ogni evento il processo dinamico che lo ha determinato (13). Se ogni phainómenon, secondo la nota formula pettazzoniana, è un genómenon (14), si può affermare allora che la storia della religione romana coincide, per Pettazzoni, con la storia delle successive trasformazioni dettate dall’esigenza di adattare le espressioni del culto di volta in volta alle mutate condizioni della cosa pubblica (15); soprattutto nel periodo post-repubblicano, essa è, per Pettazzoni, la storia delle riforme attuate «sul vecchio tronco della religione romana tradizionale e nazionale per adeguarla alle nuove esigenze del nuovo stato super-nazionale che è l’impero» (16). L’adozione del Cristianesimo come religione di stato appare dunque allo studioso solo come l’ultimo a livello cronologico di questi interventi di riforma: esso fu bensì quello definitivo, ma non comportò a suo giudizio una frattura sul piano storico. Dalla religione antica di Roma alla storia religiosa moderna, Pettazzoni vedeva i segni di una continuità che suggeriva (ma Pettazzoni scrive: «impone») lo studio della religione romana non solo come momento di un processo unitario, ma anche come strumento di allargamento della coscienza storica e come «speciale interesse nazionale» (17).
Sebbene il Congresso sia stato organizzato durante il regime Fascista, ed anzi l’Istituto per gli Studi Romani che ne fu il promotore sia stato creato proprio quegli anni per esaltare, anche in chiave propagandistico-politica, l’ideale della romanità, non vi è nelle parole di Pettazzoni da leggere un intento celebrativo (18). L’idea della storia delle religioni come strumento di allargamento della coscienza storica (19) sembra aver accompagnato Pettazzoni fin dai suoi esordi e, essendo la storia di Roma antica parte integrante della storia nazionale d’Italia, il suo studio assumeva immediatamente ai suoi occhi la funzione di promuovere l’autocoscienza del popolo italiano. A riprova del carattere non episodico dell’interesse di Pettazzoni per la storia religiosa d'Italia si può addurre anche il fatto che, a conclusione del Congresso, R. Pettazzoni propose e fece sottoscrivere, con l’appoggio anche di Gaetano De Sanctis, un ordine del giorno che impegnava a riservare una speciale attenzione all’incremento dello studio della storia della religione di Roma (20). Coerentemente con questa presa di posizione, lo studioso si dedicò, negli anni che seguirono, ad un intenso lavoro di ricerca (21), che costituì, tra l’altro, la base documentaria per un ciclo di tre lezioni sulla politica religiosa di Roma antica, tenuto presso l’Università di Padova nel marzo 1936, su invito del rettore Carlo Anti. Nella prima lezione, Roma e le religioni di mistero, Pettazzoni analizzò la politica repressiva adottata dalle istituzioni romane nei confronti dei culti di Bacco (186 a.C.), di Giove Sabazio (139 a.C.) e dei misteri egizi, fino ad arrivare alle persecuzioni contro i Cristiani (22). Attraverso lo studio dell’affaire dei Bacchanalia del 186 a. C., R. Pettazzoni ebbe modo di osservare la reazione della res publica nei confronti di un culto misterico-iniziatico (23), caratterizzato da riti orgiastici e promiscuità sessuale, che prometteva ai suoi fedeli una salvazione individuale. Tale reazione si manifestò principalmente sul piano politico: agli adepti dei culti bacchici venne mossa l’accusa di coniuratio, una forzatura certo che trasformava in crimen contro lo Stato il giuramento che imponeva agli iniziati di mantenere il segreto sulla materia sacra specifica del culto, ma una forzatura che rivela come Roma individuasse nel popolo dei Bacchanalia un pericolo per la sua sopravvivenza piuttosto che per la purezza della sua religione. Osserva a proposito Pettazzoni che la politica religiosa verso le religioni di misteriche sembra passare attraverso tre fasi: «da prima, fin che sono senza importanza, le ignora; poi, quando prendono piede, le perseguita per sradicarle; poi, quando la violenza risulta vana, le riconosce per dominarle. Sono tre fasi, tre aspetti successivi di una stessa politica, costantemente ispirata alla avversione. In fondo a questa politica sta il fondamentale irriducibile contrasto fra la religione dello stato e le religioni di miste ro» (24). Già nel saggio I misteri del 1924 Pettazzoni aveva ritenuto di poter individuare due diverse forme ed espressioni di religiosità, in costante contrasto tra loro: «Di fronte ad una religiosità dello stato, della nazione, della patria, naturalmente orientata verso l’al di qua, cioè verso la conservazione di quell’organismo sociale e politico cui l’individuo appartiene nascendo e che per l’individuo è tutto – e fuori di essa l’individuo è nulla – la religiosità dei misteri ha piuttosto carattere privato e individuale, orientata com’è prevalentemente verso le cose ultime, verso il destino di ogni singolo uomo nell’aldilà» (25).
Nell’elaborazione di questa dialettica religiosa, ripresa, ridiscussa e sempre meglio precisata in tutti gli studi di Pettazzoni dedicati a Roma antica, la religione romana forniva all’autore uno dei paradigmi della «religione dello Stato» (26), e le sue vicende storiche offrivano l’opportunità di verificare le reazioni di una religione nazionale nei confronti delle invasioni di campo (27) da parte di una forma di religione pre-nazionale (28). Pettazzoni considerava infatti i misteri una religiosità che aveva le sue origini in una fase antichissima che precedeva la creazione di forme politiche nazionali, e che dunque per ciò stesso aveva al suo interno un carattere anti-nazionale. Sotto questo profilo, anche il Cristianesimo poteva considerarsi una religione di mistero: è questo il tema della seconda lezione nella quale Pettazzoni si sofferma ad esaminare in particolare i rapporti tra il Cristianesimo e le religioni di mistero e tra il Cristianesimo e l’impero romano. Anche questo tema era stato già trattato da Pettazzoni nel saggio I misteri (29), ma nella sede accademica, alla luce anche di una maggiore attenzione nei confronti della storia della religione romana, il contrasto epocale si delinea con maggiore chiarezza (30). Invece di soffermarsi sui caratteri del Cristianesimo comuni anche alle religioni misteriche, Pettazzoni appare interessato piuttosto a definirne gli elementi differenziali; dopo un'attenta valutazione, lo studioso coglie nel passaggio da una dimensione nazionale ad una prospettiva compiutamente sopranazionale e nel suo spirito di esclusivismo gli autentici tratti di originalità del Cristianesimo rispetto agli altri misteri: «il Cr[istianesim]o è un mistero, ma un mistero sui generis». Al pari delle religioni di mistero, esso, dapprima ignorato dall'autorità imperiale romana, fu in seguito perseguitato ed infine accettato; nel contatto tra il Cristianesimo e l'impero romano, tuttavia, fu quest'ultimo ad essere assimilato. «Il C[ristianesim]o trionfatore nello St[ato] romano si fa persecutore del pagan[esimo], e nella sua persecuzione accomuna la relig[ione] pagana di stato e le relig[ioni] di mistero. Ecco un’altra differ[enza] capitale fra crist[ianesimo] e misteri; essa si rivela in questa persecuzione» (31). Nella terza ed ultima lezione, Pettazzoni affronta il tema del confronto tra la storia religiosa dell'Occidente e quella Oriente, individuando nella conversione e nel sincretismo, rispettivamente i caratteri dominanti del loro svolgimento storico (32). I temi individuati nelle lezioni patavine costituiranno per molti anni il fulcro della riflessione di Pettazzoni sulla storia della religione di Roma Antica (33). Nell'Anno Accademico 1937-1938, dedicò il suo corso istituzionale per gli studenti dell'Università La Sapienza di Roma a La religione di Augusto (34), sviluppando lo stesso argomento anche nel contributo pubblicato nel volume commemorativo del bimillenario della nascita di Augusto (63 a.C.) (35).
La trattazione dell’argomento condotta da Pettazzoni trascende in realtà i limiti cronologici imposti dalla circostanza per allargarsi ed estendersi all’intera storia della religione romana. L’attenzione dello studioso si concentra soprattutto sull’esame delle riforme di Augusto, ed in particolare sull’istituzione dei culti del Divus Iulius e del Genius Augusti (36): Pettazzoni vede in questi due interventi gli «elementi prototipici e complementari» che posero le basi per una nuova religione, la religione dell’Impero (37). Come la formula costituzionale realizzata con il principato proponeva una soluzione al problema dell’adattamento del modello di regalità ellenistico-orientale alla tradizione repubblicana romana, rimuovendo gli elementi incompatibili (forma monarchica e divinizzazione del sovrano), così le riforme religiose operate da Augusto realizzarono quell’unità religiosa necessaria a garantire la stabilità del nuovo assetto costituzionale (38). Il senso della riforma promossa da Augusto nel corpo del politeismo romano era, secondo Pettazzoni, un senso politico: «Una nuova forma di stato era necessaria e con essa una nuova religione» (39). Anche a livello religioso, l’opera di riforma–consolidamento comportò l’ablazione di quelle manifestazioni giudicate incompatibili, in primo luogo il culto druidico, dapprima consentito ai Germani ma vietato ai Romani, in seguito proibito in ogni sua forma per tutti i cittadini dell’Impero (40). Nella vittoria di Ottaviano-Apollo su Antonio-Dioniso, Pettazzoni vedeva, infine, la soluzione temporanea anche del conflitto tra «religione dello Stato» e «religione dei misteri». ![]() In tale prospettiva, la politica repressiva portata avanti da Augusto nei confronti dei culti dionisiaci, egiziani, druidici trovava la sua giustificazione nella carica eversiva dei culti stessi, in grado di minare l’unità religiosa dell’Impero tanto faticosamente raggiunta. L’indirizzo intrapreso da Augusto e continuato da Tiberio, da Claudio, dai Flavii, da Adriano sarà significativamente sconfessato da Caligola, Nerone, Commodo e Aureliano, tutti sostenitori di una monarchia a carattere divino. L’ultimo atto di questo millenario confitto si compì con l’affermazione del Cristianesimo come la religione dello stato romano: «Così –annota Pettazzoni- l’opera religiosa di Augusto finiva. L’impero non sopravvisse ai suoi iddii» (41). Ci siamo soffermati a lungo su questo contributo pettazzoniano, in quanto riteniamo che esso costituisca la più compiuta ricostruzione della religione romana realizzata dallo studioso: in esso prendono forma quelle istanze di merito e di metodo espresse da Pettazzoni al Congresso di Studi Romani, ma depurate delle componenti improduttive e arricchite di elementi innovativi. Come è apparso evidente anche da queste brevi note, l’analisi della religione romana condotta dallo studioso prescinde dall’esame del mito per concentrarsi su materiali desunti esclusivamente dall’apparato rituale e cultuale. Questa attenzione al dato rituale non ci sembra casuale, dal momento che proprio in quegli anni uscirono, quasi contemporaneamente, tre studi fondamentali per una nuova ermeneusi della storia della religione romana: Der römische Iuppiter (42); La prehistoire du flamines maiores (43); Il mito nella storia di Cecilio Metello (44). Pur nelle diversità di metodo e di approccio, ciascuna di queste opere, una delle quali concepita e realizzata nell’ambito della scuola dall’allievo di R. Pettazzoni Angelo Brelich, poneva l’accento sulla necessità di partire dal rito per recuperare l’originalità e lo specifico culturale della religione romana. Prendeva così corpo una nuova corrente di studi che distaccandosi definitivamente dalla Altertumswissenschaft proponeva attraverso l’elaborazione della teoria della demitizzazione una nuova interpretazione della religione romana (45).
In tale prospettiva, la politica repressiva portata avanti da Augusto nei confronti dei culti dionisiaci, egiziani, druidici trovava la sua giustificazione nella carica eversiva dei culti stessi, in grado di minare l’unità religiosa dell’Impero tanto faticosamente raggiunta. L’indirizzo intrapreso da Augusto e continuato da Tiberio, da Claudio, dai Flavii, da Adriano sarà significativamente sconfessato da Caligola, Nerone, Commodo e Aureliano, tutti sostenitori di una monarchia a carattere divino. L’ultimo atto di questo millenario confitto si compì con l’affermazione del Cristianesimo come la religione dello stato romano: «Così –annota Pettazzoni- l’opera religiosa di Augusto finiva. L’impero non sopravvisse ai suoi iddii» (41). Ci siamo soffermati a lungo su questo contributo pettazzoniano, in quanto riteniamo che esso costituisca la più compiuta ricostruzione della religione romana realizzata dallo studioso: in esso prendono forma quelle istanze di merito e di metodo espresse da Pettazzoni al Congresso di Studi Romani, ma depurate delle componenti improduttive e arricchite di elementi innovativi. Come è apparso evidente anche da queste brevi note, l’analisi della religione romana condotta dallo studioso prescinde dall’esame del mito per concentrarsi su materiali desunti esclusivamente dall’apparato rituale e cultuale. Questa attenzione al dato rituale non ci sembra casuale, dal momento che proprio in quegli anni uscirono, quasi contemporaneamente, tre studi fondamentali per una nuova ermeneusi della storia della religione romana: Der römische Iuppiter (42); La prehistoire du flamines maiores (43); Il mito nella storia di Cecilio Metello (44). Pur nelle diversità di metodo e di approccio, ciascuna di queste opere, una delle quali concepita e realizzata nell’ambito della scuola dall’allievo di R. Pettazzoni Angelo Brelich, poneva l’accento sulla necessità di partire dal rito per recuperare l’originalità e lo specifico culturale della religione romana. Prendeva così corpo una nuova corrente di studi che distaccandosi definitivamente dalla Altertumswissenschaft proponeva attraverso l’elaborazione della teoria della demitizzazione una nuova interpretazione della religione romana (45).
Da segnalare inoltre come nell’analisi di Pettazzoni non vi sia più alcun ricorso all’elemento magico, che appariva ancora nell’articolo 1929 (v. supra p. ). Accanto a questa significativa assenza, va segnalata l’introduzione del criterio di compatibilità/incompatibilità, utilizzato da Pettazzoni nella sua ricostruzione come criterio analitico individuante, sia a livello storico-religioso che storico-politico (46): si trattava di un criterio innovativo che consentiva di riportare alla dimensione culturale scelte operate da Augusto comunemente negli studi specialistici ricondotte a presunte caratteristiche naturalistico-psicologiche del princeps, quali la mentalità pragmatica, la lungimiranza, lo spirito pratico, la tolleranza. Questo orientamento, che si rivelerà particolarmente fecondo negli studi degli allievi ed eredi di Pettazzoni, soprattutto in Sabbatucci, ma anche in Brelich, riconduceva e risolveva in dialettiche culturali interventi in campo religioso che altrove e altrimenti sarebbero apparsi inspiegabili, immotivati e forse anche illogici. Nel quadro dell’organica connessione e interdipendenza tra piano religioso e piano politico, nel segno dell’accoglimento del compatibile e dell’abbandono dell’incompatibile, si comprendevano le ragioni che avevano condotto Augusto, che pure era stato iniziato ai misteri di Eleusi, a vietare il culto druidico ai Romani e a rifiutare il culto della sua persona in vita, promuovendo tuttavia il culto del suo Genio, ossia dell’elemento divino presente in essa, secondo una concezione tradizionale della religione romana. Sappiamo che Pettazzoni concepì in quegli anni un progetto molto più ampio relativo allo studio della religione di Roma antica, progetto destinato per molti aspetti a rimanere incompiuto. Aveva, infatti, in programma di organizzare una grande conferenza su La religione di Roma, mai realizzata, nella quale concentrare l'attenzione sul culto capitolino inteso come spirito della religione dello stato; intendeva inoltre analizzare le divinità protettrici dei personaggi carismatici del I sec. a.C. , Mario, Silla e Pompeo e dedicarsi allo studio dell'intervento di Cesare in campo religioso (47). Solo quest'ultimo progetto fu portato a termine, anche se in forma ridotta rispetto alle intenzioni dello studioso: Pettazzoni, infatti, ebbe modo di trattare La religione di Cesare in un articolo-recensione al volume omonimo di Eugenio Giovannetti apparso sulle pagine de Il Giornale d’Italia nel settembre del 1937 (48). Il contributo pettazzoniano allo studio della religione romana si completa con i lavori dedicati a singole figure divine, Ianus (49), Carna (50) e Carmenta (51), ma soprattutto con i saggi elaborati negli anni '40 (52) e riediti dall'autore in Italia religiosa (53). In quest'opera Pettazzoni si sofferma ad analizzare in particolare i momenti storici nei quali, a Roma, si manifestò la «perenne antitesi fra due forme religiose eterogenee (...), la religione dello Stato e la religione dell’Uomo» (54).
Raggiunge così la sua formulazione definitiva la dialettica religiosa individuata da Pettazzoni già negli anni Venti. Alcune interessanti correzioni sono apportate dallo studioso al paradigma precedente: innanzi tutto la definizione «religione di mistero» lascia il posto a «religione dell'Uomo» (55), una formulazione più ampia, che consente di inserire al suo interno anche il Cristianesimo, sul cui carattere misterico Pettazzoni aveva espresso delle riserve sin dalle lezioni patavine. In questa nuova formulazione, inoltre, sembra che Pettazzoni renda l’antitesi più radicale, rispetto a quanto espresso nei suoi lavori precedenti, dove lo scarto differenziale tra religione nazionale/religione misterica era presentato come di carattere storico, e non strutturale (56): lo studioso considerava infatti i misteri unareligione pre-nazionale e quindi certamente in contrasto con la «religione dello Stato», ma in qualche misura integrabile al suo interno, anche se in posizione marginale o marginalissima (57). Questa posizione poteva trovare conferma, dal punto di vista storico, per Roma proprio nel caso dei Bacchanalia, in cui, nonostante la vasta repressione attuata nei confronti degli adepti, la res publica romana con l’editto del 186 a.C. non giunse ad estirpare ogni forma di culto reso a Bacchus, ma intervenne per disciplinarne le modalità di esecuzione in modo da eliminarne le manifestazioni più aberranti ed incompatibili. Nelle pagine di Italia religiosa dedicate alla repressione dei Bacchanalia e dei vari culti misterici fino a giungere al Cristianesimo, al contrario, si delineano i tratti di un conflitto assoluto, strutturale e inevitabile tra «religione dello Stato» e «religione dell’Uomo», che si riproporrebbe, a giudizio di Pettazzoni, nella storia come nell’attualità (58) ogni volta che si trovano di fronte![]() due prospettive di salvazione, una rivolta e indirizzata all’individuo, che trascende i limiti dell’esistenza proiettandosi nell’infinito temporale, e l’altra che tende a una salvezza collettiva e terrena, da realizzarsi qui e adesso, senza nulla rinviare ad una dimensione ultramondana. Sembra quindi che la genesi di tale antitesi possa essere ricondotta all’esistenza di due istanze di tipo diverso, corrispondenti alla doppia natura del soggetto come individuo e come parte della collettività. Nei successivi capitoli, Pettazzoni, attraverso il richiamo alle vicende religiose e politiche dell’Europa nel Medioevo e nell’Età moderna, e del Giappone nell’Età contemporanea, giunge inoltre a convalidare l’idea che un carattere religioso dello Stato sia connaturato all’idea stessa di Stato e che la soppressione o (auto)soppressione di uno dei due termini del dualismo religioso assuma perciò un valore puramente formale, e non sostanziale (59). Anche in questa nuova e definitiva formulazione, tuttavia, l’apporto di Roma rimane paradigmatico fornendo essa il modello su cui lo studioso elabora il primo polo, quello dello Stato, come appare anche negli altri due saggi ospitati nel volume, Roma arcaica e Paganesimo e Cristianesimo. Nel primo, Pettazzoni analizza l’arcaica pratica della devotio, un antichissimo rito per cui il generale prima di una battaglia si offriva agli dei come votum per assicurare la vittoria al proprio esercito; la morte sul campo del generale così votatosi, scioglieva la promessa rivolta agli dei e garantiva il successo delle armi romane.
due prospettive di salvazione, una rivolta e indirizzata all’individuo, che trascende i limiti dell’esistenza proiettandosi nell’infinito temporale, e l’altra che tende a una salvezza collettiva e terrena, da realizzarsi qui e adesso, senza nulla rinviare ad una dimensione ultramondana. Sembra quindi che la genesi di tale antitesi possa essere ricondotta all’esistenza di due istanze di tipo diverso, corrispondenti alla doppia natura del soggetto come individuo e come parte della collettività. Nei successivi capitoli, Pettazzoni, attraverso il richiamo alle vicende religiose e politiche dell’Europa nel Medioevo e nell’Età moderna, e del Giappone nell’Età contemporanea, giunge inoltre a convalidare l’idea che un carattere religioso dello Stato sia connaturato all’idea stessa di Stato e che la soppressione o (auto)soppressione di uno dei due termini del dualismo religioso assuma perciò un valore puramente formale, e non sostanziale (59). Anche in questa nuova e definitiva formulazione, tuttavia, l’apporto di Roma rimane paradigmatico fornendo essa il modello su cui lo studioso elabora il primo polo, quello dello Stato, come appare anche negli altri due saggi ospitati nel volume, Roma arcaica e Paganesimo e Cristianesimo. Nel primo, Pettazzoni analizza l’arcaica pratica della devotio, un antichissimo rito per cui il generale prima di una battaglia si offriva agli dei come votum per assicurare la vittoria al proprio esercito; la morte sul campo del generale così votatosi, scioglieva la promessa rivolta agli dei e garantiva il successo delle armi romane.
Nella storia di Roma tre esponenti della famiglia dei Decii Mures si resero protagonisti della devotio ed ottennero la vittoria con il sacrificio della loro vita in tre battaglie decisive: nel 340 a.C. sul Veseri contro i Latini; nel 295 a.C. a Sentino contro la coalizione di popoli guidati dai Sanniti; nel 279 a.C. ad Ascoli Satriano contro l’esercito di Pirro. Attraverso l’analisi della figura del consul artefice del «rito tremendo e glorioso» (60) della devotio, Pettazzoni costruisce un esempio di «martire», che sembra voler dimostrare come anche all’interno della religione dello Stato vi sia spazio per esperienze per così dire di misticismo estremo. Il consul devotus che con la sua grande ombra chiama e trascina con sé nella morte i nemici assume la statura spirituale del cristiano delle origini che attraverso il martirio rendeva testimonianza della profondità della sua fede. Così, in conclusione del saggio Paganesimo e Cristianesimo, dopo aver ripercorso le tappe del conflitto tra «religione dello Stato» e «religione dell’Uomo», a partire dal 186 a.C., Pettazzoni affianca e di fatto assimila il console romano Decio Mure al vescovo di Roma Fabiano, entrambi immolatisi, uno per la salvezza dello Stato, l’altro per la salvezza della sua anima (61). Nei lavori di Pettazzoni dedicati allo studio della religione romana sembra assente quello che a partire dagli anni Quaranta del XX secolo divenne il tema centrale, ossia la teoria della demitizzazione. Lo studioso in realtà non prese mai apertamente posizione a favore o contro questa teoria né partecipò in alcun modo alla sua definizione, nonostante proprio nella stessa scuola da lui fondata due studiosi, Brelich e Sabbatucci stessero proprio in quegli anni fornendo un contributo determinante per la comprensione del processo di storificazione come modalità della demitizzazione romana.
Questo silenzio si spiega solo in parte con il richiamo alla motivazione più ovvia, ossia al fatto che tutti i contributi anche quelli pubblicati in Italia religiosa furono da Pettazzoni concepiti prima che la demitizzazione si imponesse come tema centrale nell’ermeneusi della religione romana. In realtà, a nostro avviso, la ragione reale risiede piuttosto nel fatto che Pettazzoni si impegnò, per quanto riguarda Roma, principalmente in lavori di sintesi che abbracciavano l’intero svolgimento della sua religione tratteggiando un quadro d’insieme nel segno della diacronia, rispetto alla quale la demitizzazione poteva rivelarsi un criterio scarsamente individuante, limitandosi la sua applicabilità alla sola fase repubblicana della storia di Roma. L’antitesi tra «religione dello Stato» e «religione dell’Uomo» poteva rivelarsi allora un criterio maggiormente orientativo offrendo uno schema per interpretare l’intero svolgimento della religione di Roma, ![]() dall’epoca della sua formazione fino al momento della sua definitiva scomparsa ad opera del Cristianesimo. Ma il contributo di Pettazzoni allo studio della religione romana non si esaurisce con i suoi lavori. Attraverso il rilevamento del polo dialettico «religione dello Stato» questo studioso ha offerto argomenti a favore del superamento e del definitivo abbandono della dicotomia religione/diritto che caratterizzava l'approccio alla religione romana fino alla metà del secolo scorso; in tale prospettiva, in tanti successivi studi di romanistica concepiti all’interno della Scuola storico-religiosa di Roma, si può riconoscere lo sviluppo di temi già presenti nell’opera scientifica, negli studi e nel magistero di Raffaele Pettazzoni.
dall’epoca della sua formazione fino al momento della sua definitiva scomparsa ad opera del Cristianesimo. Ma il contributo di Pettazzoni allo studio della religione romana non si esaurisce con i suoi lavori. Attraverso il rilevamento del polo dialettico «religione dello Stato» questo studioso ha offerto argomenti a favore del superamento e del definitivo abbandono della dicotomia religione/diritto che caratterizzava l'approccio alla religione romana fino alla metà del secolo scorso; in tale prospettiva, in tanti successivi studi di romanistica concepiti all’interno della Scuola storico-religiosa di Roma, si può riconoscere lo sviluppo di temi già presenti nell’opera scientifica, negli studi e nel magistero di Raffaele Pettazzoni.
Note:
1 Cfr. R. Pettazzoni, Esposizione della operosità scientifica e didattica del concorrente prof. Raffaele Pettazzoni, 1923: «Durante l'università coltivai specialmente gli studi di filologia classica e indo-europea» in M. Gandini, Raffaele Pettazzoni autodidatta nello studio della Storia delle religioni e alunno della Scuola Italiana di Archeologia (1905-1907). Materiali per una biografia, «Strada maestra. Quaderni della Biblioteca comunale «G.C. Croce» di San Giovanni in Persiceto» 32 (1992), p. 125; grazie alla sua solida preparazione filologica, R. Pettazzoni fu per un periodo docente di lettere latine e greche nel R. Liceo-Ginnasio Marco Minghetti di Bologna (A. S. 1908-09), cfr. M. Gandini, Raffaele Pettazzoni da alunno della Scuola Archeologica a professore supplente nel «Minghetti» di Bologna (19071909), «Strada Maestra» 33 (1992), pp. 198-199.
2 R. Pettazzoni, Le Superstizioni, in S. Giusti, Storia e mitologia con antologia di testi di Raffaele Pettazzoni, Roma 1988, pp. 155-165 (ed. or. Le Superstizioni, in Atti del I Congresso di Etnografia Italiana, Perugia 1912).
3 R. Pettazzoni, Le Superstizioni, cit., p. 156.
4 W. F. Otto, Religio und Superstitio, «Archiv für Religionswissenschaft» 12 (1909), pp. 518 ss.; tale etimologia appare oggi poco accreditata, cfr. W. Belardi, Superstitio, Roma 1976.
5 R. Pettazzoni, Le Superstizioni, cit., p. 159; per un inquadramento di questo contributo all’interno dell’opera di Pettazzoni, cfr. S. Giusti, Lo studio delle religioni: problemi di metodo, in S. Giusti, Storia e mitologia con antologia di testi di Raffaele Pettazzoni, cit., pp. 23 ss..
6 Cfr. M. Gandini, , Raffaele Pettazzoni autodidatta nello studio della Storia delle religioni e alunno della Scuola Italiana di Archeologia (19051907), «Strada Maestra» 32 (1992), pp. 125-142.
7 Cfr. N. Gasbarro, La terza via tracciata da Raffaele Pettazzoni, «SMSR» 56 (1990), pp. 148-153.
8 R. Pettazzoni, Per lo studio della religione dei Romani, in Atti del I° Congresso Nazionale di Studi Romani, Roma 1929, pp. 243-247.
9 R. Pettazzoni, Per lo studio della religione dei Romani, cit., p. 246.
10 Cfr. R. Pettazzoni, Per lo studio della religione dei Romani, cit., p. 244.
11 R. Pettazzoni, ibid.: «Il merito principale della scuola antropologica è stato la scoperta e la illustrazione dell’elemento magico che abbondantissimo nella religione romana, sta a rappresentare un nucleo antichissimo tramandato da epoche immemorabili».
12 R. Pettazzoni, Per lo studio della religione dei Romani, cit., p. 245; R. Pettazzoni nota come il concetto di svolgimento sia estraneo tanto all’indirizzo antiquario, quanto a quello antropologico, volto al rilevamento delle sopravvivenze; per la posizione di Pettazzoni, cfr C.T. Altan-M. Massenzio, Religioni, simboli, società: sul fondamento umano dell'esperienza religiosa, Milano 1998, pp. 51-54.
13 Cfr. R. Pettazzoni, Il metodo comparativo, «Numen» 6 (1959), pp. 1-14; su questo tema cfr. . S. Giusti, Lo studio delle religioni: problemi di metodo, cit., pp. 82 ss.; G. Mazzoleni, Il mito il rito e la storia secondo la Scuola Storico-religiosa di Roma, in Le religioni e la storia. A proposito di un metodo, a cura di G. Mazzoleni e A. Santiemma, Roma 2005, pp. 22-25.
14 R. Pettazzoni, La religione nella Grecia antica fino ad Alessandro, Bologna 19532, p. ; per le sue implicazioni, cfr. A. Santiemma, Storia, religione ed altre categorie, Le religioni e la storia. A proposito di un metodo, cit., pp. 6672.
15 R. Pettazzoni, Per lo studio della religione dei Romani, cit., p. 246.
16 R. Pettazzoni, Per lo studio della religione dei Romani, cit., p. 247.
17 R. Pettazzoni, ibid.: «Questa continuità, questo svolgimento impone a noi Italiani in particolare lo studio della religione romana e della sua storia, non per motivi estrinseci, non per non essere da meno degli stranieri, ma per nostro speciale interesse nazionale attualissimo».
18 Per la posizione di R. Pettazzoni nei confronti del Fascismo, cfr. M. Stausberg, Raffaele Pettazzoni and the History of Religions in Fascist Italy (1933-1945), in The Study of Religion under the Impact of Fascism, a cura di H. Junginger, Leiden 2008, pp. 333-368; il rapporto tra R. Pettazzoni e G. Gentile è ricostruito in V.S. Severino, Giovanni Gentile e Raffaele Pettazzoni (1922-1924). Un carteggio sulla storia delle religioni e l’università in Italia, «Storiografia» 6 (2002), pp..
19 Cfr. R. Pettazzoni, La religione nella Grecia antica fino a Alessandro, Bologna 1921, p. 22; per le critiche di M. Eliade, cfr. P. Pisi, Storicismo e fenomenologia nel pensiero di Raffaele Pettazzoni, «SMSR» 56 (1990), n. 41, pp. 264-265.
20 R. Pettazzoni, Per lo studio della religione dei Romani, cit., p. 247; cfr. M. Gandini, Raffaele Pettazzoni negli anni 1928-1929, «Strada Maestra» 48 (2000), p. 98.
21 M. Gandini, Raffaele Pettazzoni dal gennaio 1934 all’estate 1935, «Strada Maestra» 51 (2001), pp. 179-181.
22 Gli appunti di queste lezioni sono commentati ed in parte riprodotti in M. Gandini, Raffaele Pettazzoni intorno al 1935, «Strada Maestra» 52 (2002), pp. 175-180.
23 Si noti che l’aggettivo ‘misterico’ è un neologismo coniato da R. Pettazzoni ne I misteri: saggio di una teoria storico-religiosa, Catanzaro 19972 (ed. or. Bologna 1924).
24 Dagli appunti di R. Pettazzoni in M. Gandini, Raffaele Pettazzoni intorno al 1935, «Strada Maestra» 52 (2002), p. 176.
25 R. Pettazzoni, I misteri, op. cit., p. 26.
26 Opportunamente V.S. Severino, La religione di questo mondo in Raffaele Pettazzoni, Roma 2009, p. 157-8 n. 76 richiama l’attenzione degli studiosi sul fatto che la prima formulazione del concetto di «religione dello Stato» si rinviene ne La religione di Zarathustra nella storia religiosa dell’Iran, Bologna 1920, un lavoro pubblicato quando ancora il Partito Nazionale Fascista non era al potere; un altro paradigma di «religione dello Stato» era rappresentato per Pettazzoni dallo shintoismo, religione ufficiale del Giappone, cfr. E. Montanari, Categorie e forme nella Storia delle religioni, cit., pp. 22-23.
27 L’espressione è ripresa da E. Montanari, Categorie e forme nella Storia delle religioni, cit., p. 18.
28 R. Pettazzoni Religioni nazionali, supernazionali e misteriche, in Saggi di storia delle religioni e di mitologia, Roma 1946, pp. 153-168.
29 R. Pettazzoni, I misteri, op. cit., pp. 311-328 (I misteri e il cristianesimo).
30 E' evidente in questo caso il richiamo al fortunato saggio di A. Loisy, Les mystères paiens et le mystère chrétien, Paris 19302.
31 Dagli appunti di R. Pettazzoni in M. Gandini, Raffaele Pettazzoni intorno al 1935, «Strada Maestra» 52 (2002), p. 177 (integrazioni a cura della redattrice).
32 Cfr. M. Gandini, Raffaele Pettazzoni intorno al 1935, «Strada Maestra» 52 (2002), p. 178-180.
33 Il testo delle tre lezioni appare rielaborato in diversi articoli e saggi: Religioni nazionali, supernazionali e misteriche, cit.; A functional view of religions, «The Rewiew of Religion» 1 (1936-37), pp. 225-237; Oriente e Occidente: tradizioni antiche e prospettive nuove, «Rendiconti dell’Accademia dei Lincei», 6 (1959), pp. 75-80.
34 Le lezioni di questo corso sono conservate in un manoscritto di oltre cinquanta pagine, redatto con una scrittura fittissima, cfr. M. Gandini, Il corso di Storia delle religioni dell’a.acc. 1937-38, «Strada Maestra» 54 (2003), pp. 129-130; per il programma cfr. M. Gandini, Raffaele Pettazzoni negli anni 1937-1938, «Strada Maestra» 54 (2003), p. 130.
35 R. Pettazzoni, La religione, in Augustus: studi in occasione del bimillenario Augusteo, a cura di V. Arangio-Ruiz, Roma 1938, pp. 217-249.
36 R. Pettazzoni, La religione, cit.. pp. 223-227.
37 R. Pettazzoni, La religione, cit., p. 226.
38 R. Pettazzoni, La religione, cit., pp. 233-234.
39 R. Pettazzoni, La religione, cit., p. 233.
40 R. Pettazzoni, La religione, cit., p. 238.
41 R. Pettazzoni, La religione, cit., p. 244.
42 C. Koch, Der römische Iuppiter, Frankfurt a.M. 1937.
43 G. Dumézil, La préhistoire des flamines majeurs, «Revue de l'histoire des religions» 118 (1938), pp. 188-200.
44 A. Brelich, Il mito nella storia di Cecilio Metello, «SMSR» 15 (1939), pp. 30-41.
45 Per gli sviluppi della teoria della demitizzazione nell’opera dei diversi studiosi, cfr. E. Montanari, Identità culturale conflitti religiosi nella Roma repubblicana, Roma 1988, pp. 17-60.
46 R. Pettazzoni , La religione, cit., p. 238 e p. 240.
47 M. Gandini, Nei primi mesi del 1937: pubblicazioni attese, lavori in corso, progetti vari per il futuro, nuove recensioni, Raffaele Pettazzoni negli anni 1937-1938, «Strada Maestra» 54 (2003), pp. 63-64.
48 Cfr. M. Gandini Raffaele Pettazzoni negli anni 1937-1938, «Strada Maestra» 54 (2003), pp. 107-108.
49 R. Pettazzoni , Ianus
50 R. Pettazzoni, Carna, «SE» 14 (1940), pp. 163-172.
51 R. Pettazzoni, Carmenta, «SMSR» 17 (1941), pp. 1-16; ristampato, con lievi modifiche in traduzione inglese, negli Essays on the history of religions, Leiden 1954, pp. 110-124
52 Raffaele Pettazzoni preparò per le celebrazioni del bimillenario della nascita di Livio una relazione dal titolo Religione dello Stato e religione di mistero nella persecuzione dei Baccanali (Livio, libro XXXIX, 8-19) pronunciata il 12 febbraio 1942 e in seguito pubblicata con il titolo La Religione dei Baccanali e lo Stato Romano (Livio, lib. XXXIX, capp. 8-19), «Il libro italiano nel mondo», 3 (1942), pp. 7-11 (ora in R. Pettazzoni, Religione e società, a cura di M. Gandini, Bologna 1966, pp. 143-154); la relazione, leggermente rielaborata, confluirà in Italia religiosa, Bari 1952, e sarà edita anche in francese con il titolo Religion de l'Etat et religion de l'Homme, «La Revue de culture européenne», 3 (1953), pp. 45-55 e in inglese con il titolo State Religion and Individual Religion in the Religious History of Italy, in Essays on the History of Religions, cit., pp. 202-214; altri due saggi, presenti in Italia religiosa, cit., pp. 29-36 e 37-52 furono elaborati dall'autore per un volume tripartito sulle radici religiose dell’eroismo in Giappone, in Italia e in Germania, al quale Pettazzoni fu chiamato a collaborare nel 1941; il progetto editoriale, che prevedeva tre versioni in giapponese, italiano e tedesco della stessa opera, non venne mai realizzato, cfr. M. Gandini, Raffaele Pettazzoni nei primi anni Quaranta (1941-1943), «Strada Maestra» 56 (2004), pp. 124-127.
53 Le vicende di questo volume sono ricostruite nell'articolo di L. Sacco, Italia religiosa. Un “enigma” storiografico, «Storiografia» 8 (2004), pp. 199222.
54 R. Pettazzoni, Italia religiosa, cit., pp. 7-8: «la storia religiosa d’Italia mi si delinea nella continuità del suo svolgimento, che trascende la cesura fra paganesimo e Cristianesimo in una perenne antitesi fra due forme religiose eterogenee che io chiamerò qui la religione dello Stato e la religione dell’Uomo».
55 Per la «religione dell'Uomo», cfr. V.S. Severino, La religione di questo mondo in Raffaele Pettazzoni, Roma 2009.
56 Profonde riserve furono espresse a proposito da E. de Martino nella sua recensione a Italia religiosa apparsa su «Il Mondo», 14/3/1953, p. 6, per l’accoglienza del volume nel mondo intellettuale dell’epoca, cfr. S. Giusti, Storia delle religioni: problemi di metodo, cit., pp. 122-127; riserve altrettanto profonde, anche se di segno diverso, sono formulate da V. Lanternari, nella Prefazione a A. Rivera, Il mago, il santo, la morte, la festa: forme religiose nella cultura popolare, Bari 1988, pp. 7-8, che classifica tale antitesi come «di ordine genericamente fenomenologico».
57 Cfr. R. Pettazzoni, Religioni nazionali, supernazionali e misteriche, cit., pp. 164-166.
58 R. Pettazzoni, Italia religiosa, cit., p. 15: «un conflitto di ieri e di oggi, un conflitto di sempre».
59 R. Pettazzoni, Italia religiosa, cit., p. 24.
60 R. Pettazzoni, Italia religiosa, cit., p. 43.
61 R. Pettazzoni, Italia religiosa, cit., p. 52.
Prof. ssa Claudia Santi
Università della Campania Luigi Vanvitelli
Dipartimento di Lettere e Beni Culturali
L'articolo La Religione Romana negli studi di Raffaele Pettazzoni – Claudia Santi proviene da EreticaMente.