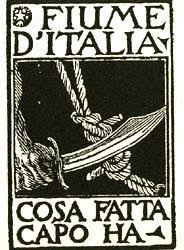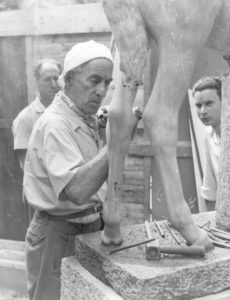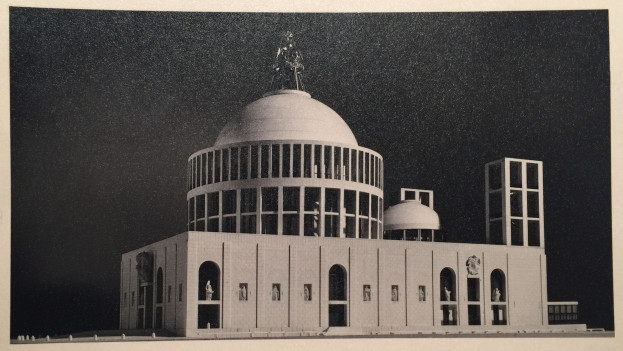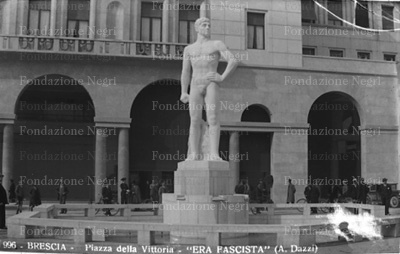![]()
È opinione (fin troppo diffusa) presso gli studiosi di Storia delle Religioni che le divinità di Roma siano state plasmate a partire da quelle degli Etruschi e dei Greci, se non addirittura di popolazioni mesopotamiche, quasi che il popolo romano fosse stato incapace di avere una qualche idea su come si concepiscano gli Dèi, e che queste divinità altro non siano, nel migliore dei casi, che personificazioni delle forze della natura, dei procedimenti agricoli o di atti particolari della vita quotidiana. Sulla base di questa errata concezione Giano è un portiere che sorveglia chi entra e chi esce, Saturno è un protettore dell’agricoltura, Vertumno si occupa dei frutti autunnali, Vulcano è un fabbro zoppo, Vesta una brava donna che bada che il fuoco di casa rimanga acceso, Marte un guerriero coperto del sangue dei suoi nemici e Venere una donnina allegra. Un esame delle fonti originali e dei miti (1) conduce invece a risultati decisamente molto differenti: le divinità greche da cui vengono fatte derivare quelle romane hanno caratteristiche e funzioni che ne fanno figure del tutto discordanti rispetto a quelle degli Dèi romani, anzi nel caso degli Etruschi sono invece questi ad avere mutuato da Roma e dai Latini una parte del loro pantheon; il pantheon di Roma risulta in realtà costituito da figure archetipiche nelle quali si riconoscono le idee principiali costituenti la sfera divina che governa il mondo creato.
GLI DÈI DI ROMA
Gli Dèi di Roma non sono comparabili ad esseri umani come quelli greci, non vi è traccia per il periodo arcaico di una “mitologia degli Dèi”, non vi sono storie concernenti episodi della loro “vita” se non dopo che l’Urbe subì la “invasione culturale” dei greci, e testimonianza di questa non-mitologizzazione degli Dèi romani è l’assenza di statue che li raffigurano se non successivamente all’intensificarsi dei rapporti con le nazioni etrusca e greca, presso le quali invece gli Dèi erano rappresentati nelle statue e nei dipinti in forma umana e secondo le modalità espositive caratteristiche di questi popoli. Voler descrivere per esteso il vero significato di ciascuno degli Dèi di Roma è fuor di luogo in questo àmbito, per cui rimandiamo alle pubblicazioni che abbiamo definito “le biografie degli Dèi” (2) e in particolare al nostro saggio sulle feste romane (3), mentre qui riassumeremo solo i caratteri principali di alcune delle divinità di Roma.
- GIANO
Secondo gli autori latini Giano, del quale in Grecia non esiste un Dio corrispondente, è il primo e più antico degli Dèi di Roma: “Su questa terra che ora vien detta Italia regnò Giano che, come narra Igino sull’autorità di Protarco di Tralli, divideva paritariamente il potere con Camese, anch'egli indi¬geno (4), sì che il paese era chiamato Camesena e la roccaforte Giani¬colo” (5). la Prima ![]() Roma, che ebbe nome Antipolis. Per la recente storiografia archeologica (6) Giano è una divinità precedente l’arrivo dei Siculi sui colli di Roma: egli rimarrà sempre il primo Dio, anche se con il passare dei secoli gli stessi Romani non sapranno più decifrarne il significato sapienziale. La sua raffigurazione come Dio bicipite, probabilmente da riferire ad una fase preindoeuropea di occupazione dell’Italia (7), ne indica la funzione di Dio del passaggio, dell’entrare e dell’uscire dal mondo fisico come da quello spirituale, colui che conosce il passato ed il presente, signore dei prima, mentre Giove è signore dei summa (8): suo sacerdote è il Rex Sacrorum, il primo dei sacerdotes, il quale ha nelle cerimonie il posto e i riti che erano propri del Re, e Giano è per eccellenza la fonte della regalità e l’archetipo del Re, funzione che più tardi passerà a Juppiter.
Roma, che ebbe nome Antipolis. Per la recente storiografia archeologica (6) Giano è una divinità precedente l’arrivo dei Siculi sui colli di Roma: egli rimarrà sempre il primo Dio, anche se con il passare dei secoli gli stessi Romani non sapranno più decifrarne il significato sapienziale. La sua raffigurazione come Dio bicipite, probabilmente da riferire ad una fase preindoeuropea di occupazione dell’Italia (7), ne indica la funzione di Dio del passaggio, dell’entrare e dell’uscire dal mondo fisico come da quello spirituale, colui che conosce il passato ed il presente, signore dei prima, mentre Giove è signore dei summa (8): suo sacerdote è il Rex Sacrorum, il primo dei sacerdotes, il quale ha nelle cerimonie il posto e i riti che erano propri del Re, e Giano è per eccellenza la fonte della regalità e l’archetipo del Re, funzione che più tardi passerà a Juppiter.
Il nome stesso di Giano, Janus, indica il pas¬saggio, derivando dalla radice indoeuropea *ya (sanscrito yana = la via, latino ire = andare, come già aveva scritto Macrobio 9 ). In quanto primo e più antico, Giano è “colui che precede tutti gli altri Dèi, Ja¬nus Pater, il fuoco celeste che costituisce l’origine prima, il Principio di ogni generazione” (10), forse in origine ritenuto dai Romani come creatore dell’esistente, considerato che Ovidio dice di lui: “Io che ero stato mole rotonda ed informe / presi l’aspetto e il corpo convenienti ad un Dio” (11), passaggio dal non-differenziato al differenziato che indica la manifestazione della divinità in una forma concepibile per l’uomo. La capacità generatrice di Giano è connessa alla sua identificazione con il Sole e con il Fuoco cosmico grazie al quale viene in essere la creazione: “Certuni vogliono dimostrare che Giano è il sole, e quindi ‘gemino’ o duplice in quanto signore di ambe¬due le porte celesti: nascendo apre il giorno e tramontando lo chiude… La sua statua tiene nella mano destra il numero 300 e nella sinistra il 65 a simbolo della durata dell'anno, dominio specifico del sole” (12).
- SATURNO
Altra divinità antichissima nel pantheon romano è Saturno, che non ha in comune con il greco Kronos se non il rapporto con il tempo, mentre non ne condivide altre caratteristiche, quali ad esempio il divorare i suoi figli. Saturno, al quale venne dedicato alle pendici del Campidoglio il primo altare di Roma al tempo di Saturnia, la Seconda Roma, altare a lui dedicato dagli Aborigeni che avevano cacciato i Siculi dalla regione (13), trae il suo nome dalla radice indoeuropea *sat (14), da cui deri¬vano in latino satis e satur, termini indicanti pienezza e soddisfazione, conseguenti all’abbondanza dei campi coltivati grazie alle tecniche da lui insegnate agli uomini, tra cui l’uso del concime (15), e sates (16), i campi seminati, in quanto a lui si attribuiva la conoscenza delle tecniche agricole: “A lui si fa risalire la pratica del trapianto e dell'innesto nella coltivazione degli alberi da frutta e la tecnica di ogni altro procedimento agrario” (17). Da qui trae origine la rappresentazione di Saturno con il falcetto (che diventerà la falce quando Saturno sarà confuso con il greco Kronos, divinità del trascorrere del tempo), per Macrobio (18) donato dallo stesso Giano al Dio, e segno della ricchezza, perché il falcetto è in rapporto non con la semina dei campi ma con la raccolta di quanto da essi prodotto. In un certo senso Saturno dà inizio al tempo, in quanto se Giano è “al di fuori della storia” ed è il Dio che dà inizio (19) al processo che porterà alla Roma storica ed assiste immutabile ed imperturbabile agli avvenimenti con una presenza costante ma “al di sopra delle parti”, Saturno è, per così dire, all’inizio della “storia mitica” (20), poiché costitui¬sce il principio della civiltà, ma egli è anche alla fine del tempo, come dimostra la sua posizione calendariale con i Saturnalia posti al centro del mese di Dicembre e subito prima delle celebrazioni dedicate alla Dèa che conclude l’anno, Angerona, il che lo rende anche una divinità “pericolosa”. Questa sua “qualità pericolosa” è chiarita da Gellio, il quale riferisce (21) di aver trovato nelle preghiere pubbliche (“conprecationes Deum immortalium, quae ritu Romano fiunt”) riportate nei Libri Pontificales e in molte antiche orazioni il nome di una “qualità del Dio”, Lua Saturni, cioè la “Dissoluzione di Saturno”, chiamata da altri Autori Lua Mater (22). La “qualità” di un Dio corrisponde ad una sua fun¬zione considerata come divinità a se stante, così come Salacia è lo “Scaturimento” delle sorgenti sotterranee di Nettuno, Neriene Martis è la “Virilità” di Marte, ecc.: questa “qualità” di Saturno entra in modo particolare in azione nella cerimonia con cui si distruggevano le armi prese al nemico. Può sembrare a prima vista strano che la “dissoluzione” possa essere la “qualità” di una divinità apparentemente pacifica e civilizzatrice per eccellenza, ma Saturno è in realtà un Dio “pericoloso” per il suo essere, come si è detto, il “Dio della fine” temporale dell’anno che coincide con la fine di ogni legge posta a stabilire i limiti della convivenza civile, lasciando aperta la via alla libertà assoluta (23), libertà appunto pericolosa perché può essere mal utilizzata da chi non sa usarne nel modo dovuto.
- VERTUMNO
Vertumno o Vortumno, considerato uno degli Dèi “minori” di Roma (se mai un Dio può essere definito minore), è un Dio così arcaico che di lui poche tracce rimangono nell’archeologia, nella letteratura e nella religione di Roma, tanto da poter pensare che si tratti![]() di quello che gli antropologi definiscono un deus otiosus, un Dio di tale antichità che le sue funzioni sono state trasferite ad altri Dèi e di lui è rimasto nel ricordo poco più che il nome. Il suo nome secondo Devoto (24) sarebbe passato dal vocabolario protolatino nel vocabolario protoetrusco in una fase antichissima di formazione del linguaggio, dando origine a Voltumna o Veltumna, il Dio venerato nel Fanum Voltumnae a Volsinii, mentre non esiste una divinità a lui corrispondente nel mondo greco (il semidio Proteo ha caratteri del tutto diversi da Vertumno). Ovidio in Metamorfosi XIV e Properzio in Elegie IV, 2, a cui rimandiamo, ci dànno gli elementi per comprendere chi sia in realtà Vortumno, un Dio antichissimo, conosciuto in Roma dal tempo degli ultimi re di Alba Longa della stirpe di Ascanio (25), in origine aniconico (26), non una divinità agricola dell’Autunno come si crede ma il signore dell’eterno mutamento (27), ed infatti il suo nome deriva secondo Devoto dalla radice verbale indoeuropea *wert, che dà in latino vertere e vortere “volgere” e in antico indiano parole con significato di “essere” ma anche “esistere”; secondo Radke (28) invece il nome deriverebbe da *vorta,*ur-tā o da *vortus, *or-tu, indoeuropeo *uŏr, *uĕr, che si ritrova in parole aventi significato di “amicizia, sicurezza, unione fra gli uomini e gli Dèi” e quindi “adempimento, esaudimento, cerimonia religiosa”, per cui Vortumno sarebbe “colui che porta o avvia il *vorta (compimento, esaudimento) del rito”, funzione che lo potrebbe collegare a Giano in quanto questi è il primo Dio invocato nelle formule rituali.
di quello che gli antropologi definiscono un deus otiosus, un Dio di tale antichità che le sue funzioni sono state trasferite ad altri Dèi e di lui è rimasto nel ricordo poco più che il nome. Il suo nome secondo Devoto (24) sarebbe passato dal vocabolario protolatino nel vocabolario protoetrusco in una fase antichissima di formazione del linguaggio, dando origine a Voltumna o Veltumna, il Dio venerato nel Fanum Voltumnae a Volsinii, mentre non esiste una divinità a lui corrispondente nel mondo greco (il semidio Proteo ha caratteri del tutto diversi da Vertumno). Ovidio in Metamorfosi XIV e Properzio in Elegie IV, 2, a cui rimandiamo, ci dànno gli elementi per comprendere chi sia in realtà Vortumno, un Dio antichissimo, conosciuto in Roma dal tempo degli ultimi re di Alba Longa della stirpe di Ascanio (25), in origine aniconico (26), non una divinità agricola dell’Autunno come si crede ma il signore dell’eterno mutamento (27), ed infatti il suo nome deriva secondo Devoto dalla radice verbale indoeuropea *wert, che dà in latino vertere e vortere “volgere” e in antico indiano parole con significato di “essere” ma anche “esistere”; secondo Radke (28) invece il nome deriverebbe da *vorta,*ur-tā o da *vortus, *or-tu, indoeuropeo *uŏr, *uĕr, che si ritrova in parole aventi significato di “amicizia, sicurezza, unione fra gli uomini e gli Dèi” e quindi “adempimento, esaudimento, cerimonia religiosa”, per cui Vortumno sarebbe “colui che porta o avvia il *vorta (compimento, esaudimento) del rito”, funzione che lo potrebbe collegare a Giano in quanto questi è il primo Dio invocato nelle formule rituali.
È stato osservato che questa sua capacità di trasformarsi si manifesta solo attraverso immagini umane o divine (può trasformarsi anche in Apollo e in Bacco, stando alle parole di Properzio 29), ma non di animali o di fenomeni meteorologici o altro ancora, a differenza di Zeus e del greco Proteo. La capacità di Vortumno di “vertere in omnia”, secondo un’altra etimologia del suo nome come Vert-umnus = vert-(in)-omnis (30), non comprende solo la sfera degli esseri umani e divini ma si estende anche ad una funzione più ampia, quella di tutela sul buono e cattivo andamento delle fortune dell’individuo. Infatti Orazio (31) ci conserva un curioso modo di dire latino: “È nato con tutti i Vertumni sfavorevoli”, chiarito da Elio Donato (32), grammatico del IV secolo d.C., il quale nel suo commento all’opera di Terenzio spiega che la frase “Di bene vertant”, “che gli Dèi la mandino buon fine”, si spiega con il fatto che “il potere che gli eventi vadano nell’uno o nell’altro modo era per gli antichi una prerogativa di Vortumno”, perché “il Dio che presiede agli eventi affinché vadano secondo i desideri di ognuno è Vortumno”. Ma esiste un’ulteriore significato di questa divinità: la particolare localizzazione della statua di Vortumno sulla via triumphalis eretta nel Vicus Tuscus (di cui era ritenuto autore il mitico artefice Mamurio Veturio), la posizione del suo tempio sull’Aventino tra l’Armilustrium e il sepolcro di Tito Tazio, co-reggente insieme a Romolo della Quarta Roma, e non ultimo i caratteri dell’etrusco Veltumna, raffigurato nello specchio di Tuscania come un giovane Dio guerriero (33), consentono di ipotizzare che in una fase arcaica della storia di Roma Vortumno avesse un ruolo anche guerriero, di cui si è poi persa ogni traccia, e in particolare fosse connesso alle cerimonie del trionfo militare.
- VULCANO
Anche nel caso di Vulcano i suoi caratteri originari sono andati perduti con il sopraggiungere della interpretatio graeca, con cui Vulcano venne identificato con Efesto, e sono forse recuperabili per mezzo di quanto scritto dagli autori latini e dai luoghi di culto in cui veniva venerato, nonché da un esame degli eroi considerati suoi discendenti, i “figli di Vulcano”, e delle fratrie di fabbri a lui connesse per l’attività di forgiatori dei metalli con il fuoco. La connessione di Vulcano (34) con il fuoco è insita nell’etimologia del nome: gli Autori moderni lo rapportano alla radice *ulka da cui “tizzone” (35), sottolineandone il carattere igneo; Varrone (36) invece lo fa derivare da fulgur e fulmen: “Vulcano è detto così dalla grande forza e violenza del fuoco”, significato che ben lo connette alla furia vulcanica di cui diremo più oltre, mentre lo Skeat (37) lo fa derivare dal sanscrito varchar con significato di “luminoso”. Il “fuoco” di Vulcano è un fuoco al tempo stesso protettore e distruttore, il che lo rende un Dio “pericoloso”, ed infatti a lui era stato dedicato un altare antichissimo da Tito Tazio (38) ma nell’area del Foro Romano prima che esso esistesse, quindi fuori dell’abitato della Roma romulea. Sull’ara Volcani (identificata dal Coarelli (39) con quello c![]() he viene erroneamente chiamato Lapis niger) fin dall’età monarchica venivano bruciate le armi prese al nemico (40)ma in particolare quelle di chi si era offerto nella devotio quando colui che si era votato alla distruzione del nemico offrendo la propria vita era invece sopravissuto all’impresa (41): qui si rivela il doppio carattere di Vulcano, la cui capacità distruttiva per mezzo del fuoco doveva essere rivolta contro l’esterno, cioè contro il nemico, come anche, sul piano magico, contro le armi “pericolose” del devotus, “pericolose” perché caricate magicamente di volontà distruttiva. Accanto alla funzione di protettore di Roma Vulcano aveva presumibilmente anche quella di iniziatore dei giovani, come si potrebbe dedurre dal fatto che egli era considerato il padre dei Cabìri, degli Onnes, dei Calìbi e delle Telchinie, fratrie di Dèi o sacerdoti esperti nell’arte metallurgica ma anche aventi attività profetica e, almeno per alcuni di esse, connesse a rituali iniziatici. I fabbri, per la loro attività, possiedono i segreti della preparazione del ferro e dei metalli, segreti che vengono trasmessi solo ai loro discepoli, e sono rappresentati da quei “gruppi di personaggi mitici – Telchini, Cabìri, Cureti, Dattili – in rapporto assai stretto con il mondo ctonico (venivano presentati in caverne), con i metalli che lavoravano, con la musica e la danza, con la magia, con i culti misterici e i riti iniziatici giovanili” (42).
he viene erroneamente chiamato Lapis niger) fin dall’età monarchica venivano bruciate le armi prese al nemico (40)ma in particolare quelle di chi si era offerto nella devotio quando colui che si era votato alla distruzione del nemico offrendo la propria vita era invece sopravissuto all’impresa (41): qui si rivela il doppio carattere di Vulcano, la cui capacità distruttiva per mezzo del fuoco doveva essere rivolta contro l’esterno, cioè contro il nemico, come anche, sul piano magico, contro le armi “pericolose” del devotus, “pericolose” perché caricate magicamente di volontà distruttiva. Accanto alla funzione di protettore di Roma Vulcano aveva presumibilmente anche quella di iniziatore dei giovani, come si potrebbe dedurre dal fatto che egli era considerato il padre dei Cabìri, degli Onnes, dei Calìbi e delle Telchinie, fratrie di Dèi o sacerdoti esperti nell’arte metallurgica ma anche aventi attività profetica e, almeno per alcuni di esse, connesse a rituali iniziatici. I fabbri, per la loro attività, possiedono i segreti della preparazione del ferro e dei metalli, segreti che vengono trasmessi solo ai loro discepoli, e sono rappresentati da quei “gruppi di personaggi mitici – Telchini, Cabìri, Cureti, Dattili – in rapporto assai stretto con il mondo ctonico (venivano presentati in caverne), con i metalli che lavoravano, con la musica e la danza, con la magia, con i culti misterici e i riti iniziatici giovanili” (42).
Dalla sua connessione con le attività sotterranee dei fabbri che traevano dalle profondità della terra i minerali da lavorare si potrebbe dedurre che Vulcano fosse il Dio del Fuoco sotterraneo, il fuoco dei vulcani ancora attivi al tempo della Roma storica: secondo gli Autori che hanno scritto della Saturnia Tellus (in particolare Di Nardo 43) egli sarebbe l’immagine dell’attività distruttiva del Monte Albano, per cui l’espressione di Festo circa l’offerta a Vulcano nel rituale privato (44) di piccoli pesci in cambio di esseri umani viene da essi interpretata come sostituto dei sacrifici umani fatti al Dio per scongiurare i tremendi effetti distruttivi delle eruzioni. Si noti che le vittime a lui destinate dovevano essere offerte in olocausto, cioè bruciate completamente, a differenza di quanto accadeva nel consueto sacrificio offerto agli altri Dèi. Da tutto quanto brevemente esposto risulta evidente che Vulcano non si limita ad essere un semplice fabbro e pure zoppo (questo per la contaminazione con l’Efesto greco) ma era figura di un Dio creatore e protettore, forse collegato ai rituali iniziatici propri delle fratrie di fabbri, probabilmente con i caratteri di un “fuoco sotterraneo” ed interiore capace di proteggere e di distruggere.
- VESTA
In apparenza Vesta compare nella storia archeologica di Roma nel periodo monarchico, quando viene costruito il suo tempio nell’area tra le pendici del Germalo e il Campidoglio; in realtà essa non era una nuova Dèa importata dalla Grecia, come alcuni autori pensano identificandola con Hestia, ma l’ultima personificazione divina di una serie di Dèe che erano venerate fin dalla più remota antichità, alle quali era attribuita una “specializzazione” del ruolo sacrale: “Vesta appare come la traduzione in culto pubblico e civico di una più antica divinità della terra, che permane come culto privato e segreto della casa del re: il culto di Ops, che potrebbe quindi essere intesa come la Vesta della dimora dei capi pre-urbani e proto-urbani succeduti a Caco sul Germalus (la Ops di Caco era Caca, venerata in seguito non a caso dalle Vestali). Vesta appare come il fuoco del focolare centrale della città, non sappiamo se coincidente con il fuoco del focolare del re” (45). Alle parole di Carandini dobbiamo obiettare che in primo luogo Vesta non è il “fuoco” ma il “focolare” sede del fuoco, in secondo luogo, per la sua condizione di Madre e Vergine, essa non coincide con una “divinità della terra”, funzione che spetta a Tellus, a Cerere e ad altre divinità consimili, ma è la “potenzialità creatrice” che attende l’azione di un “potere creatore” per generare non sul piano materiale (le messi o il bestiame) ma su quello immateriale del Potere la figura archetipica del Rex. È da rilevare che Vesta è l’ultima divinità romana a rimanere aniconica, come lo erano state tutte le altre in precedenza; come scrive Ovidio: “Fui a lungo così stolto da pensare esistesse una statua di Vesta, / ora ho imparato che nulla vi è sotto il tetto emisferico [del suo tempio]” (46). Forse per questa sua aniconicità, come suppone il Dumézil (47), essa non figura su alcuna moneta romana dell’antica serie detta “della prora di nave” (48). Vesta è divinità specifica deI Latini, i quali, soli tra tutte le popolazioni di ceppo indoeuropeo migrate nella penisola italica, ebbero e conservarono fino ai tempi storici il sacro culto del focolare (assente tra gli altri italici come presso i germani 49) e un corpo di sacerdotesse che di esso fossero le custodi.![]()
Per quanto riguarda poi la derivazione di Vesta dalla greca Hestia, il Giannelli, pur essendo un assertore di tale identificazione, deve infine ammettere che “pur essendo la Vesta di stato romana, come divinità, una derivazione della κοινη εστια delle città elleniche, sarebbe vano tentare qualsiasi ravvicinamento tra il servizio del focolare di stato in Roma e quello dei Pritanei della Grecia… Le dissomiglianze fra il culto di Vesta presso il popolo Romano e quello delle κοιναι εστιαι nei Pritanei delle città greche sono oltremodo notevoli” (50). Mentre Hestia deriva da una radice *sueit con significato di “bruciare”, per cui Hestia è *suit-tia “il fuoco del focolare”, Vesta è da *wes (51), “abitare, dimorare” e quindi è la divinità della casa stessa, la quale in un certo senso custodisce tra le sue pareti il focolare. Se Vesta è il Focolare, ad essa deve corrispondere un Dio che sia il Fuoco (52) che vi arde, e se Vesta è Madre del popolo romano (53) il suo corrispondente deve avere le caratteristiche del Padre creatore, ma è arduo sapere il suo nome, perché nulla di certo possiamo dirne. Possiamo però ipotizzare che il Dio-Fuoco correlato a Vesta possa essere Giano, facendo nostre le parole di Baistrocchi: “Tale attribuzione dovrebbe con ogni verosimiglianza essere riservata a colui che precede tutti gli altri Dèi, Ianus Pater, il fuoco celeste che costituisce l’origine prima, il Principio di ogni generazione” (54). Dumézil conferma il rapporto tra Giano e Vesta e lo dimostra dal punto di vista rituale (55): il Rex Sacrorum è il sacerdote di Giano e il Pontefice Massimo, per la sua stretta correlazione con Vesta e le sacerdotesse vestali, può essere considerato il sacerdote della Dèa, e in tal caso l’ordine in cui i cinque sacerdoti principali, il Rex Sacrorum, i tre Flamini maggiori e il Pontefice Massimo, prendevano posto nei banchetti sacri manifesta in modo chiaro che il sacerdote di Giano è il primo e quello di Vesta l’ultimo; analogamente da altri scrittori romani viene affermato che nelle preghiere e nei sacrifici il primo posto spetta a Giano e l’ultimo a Vesta (56), in quanto il primo apre, essendo questa in modo eminente la sua funzione, e la seconda, punto di contatto tra il mondo degli Dèi e quello degli uomini, chiude ogni atto religioso. La capacità generatrice di Giano è connessa alla sua identificazione con il Sole, come scrive Macrobio (57): “Il sole, prosciugando l'umidità, diede ori¬gine alla vita… Per questo anche noi chiamiamo Giano padre, venerando con tale nome il Sole”. A differenza di quanto scrive Baistrocchi, che “la Dèa impersonava anche la maternità esuberante e prolifica”, ricordiamo che Vesta non è collegata, neanche nei miti tardivi, alla procreazione ma è sempre Vergine e tale rimane pur avendo l’appellativo di Madre, come afferma Dumézil “A differenza di Tellus e di Cerere, che sono fecondanti, produttrici, essa non presiede che all’elaborazione dell’alimento e ciò che le interessa è il pane, non il grano”, quasi agisse come motore immobile e passivo della Creazione.
- VENERE
Venere è forse la divinità che più di tutte ha subìto gli effetti negativi dell’interpretatio graeca e dei contatti tra Roma e le culture del Vicino e del Medio Oriente, con uno scadimento delle sue funzioni da Dèa della Grazia divina e signora della Vittoria e della regalità al ruolo di protettrice degli accoppiamenti, con tutte le varianti erotiche connesse dal matrimonio alla prostituzione. Nel nome della Dèa ritroviamo il suo più arcaico e profondo significato: per gli autori classici Venere veniva fatto derivare da vincire = “avvincere, unire” (58), etimologia tarda che la collega al mondo dell’eros, mentre il suo nome va invece riportato ad un neutro astratto *venus sostantivizzato al femminile, il cui significato è espresso dal verbo venerari, come chiarisce Dumézil (59): “Venerari è ‘cercare di piacere’, ‘rendere dei favori al Dio’, sperando di riceverne in cambio, senza negoziazione, un’altra forma di cortesia, la venia divina. [Venerari] non designa propriamente un atto religioso di amore, di bhakti: la pietà romana non comporta effusioni”, e venerari è letteralmente “esercitare la venus” nei confronti di un Dio, non secondo quel rapporto che potremmo chiamare “giuridico” che lega il romano alle sue divinità né tanto meno fideistico ma chiedendo ad esse un favore, una buona disposizione verso di sé. Venere è la signora della Grazia come potere magico (venia) che viene incontro alle richieste dei suoi fedeli, e questa forma del potere si rivela nella parola venenum (da venes-uom), che prima di divenire “veleno” nell’accezione attuale del termine è in realtà “filtro”, significante l’azione oscura della pozione magica e per esteso la modalità misteriosa con cui essa agisce. Questa azione di Venere è quella che altrove abbiamo chiamato “il potere venusiano”, che costituisce l’aspetto opposto alla modalità quasi contrattuale con la quale il romano chiede al suo Dio di realizzare ciò che domanda, il do ut des in cui si ha uno scambio potremmo dire alla pari tra uomo e divinità.![]()
Il dominio di Venere, basato sul rapporto tra l’uomo che la venera e la Dèa che concede la venia, è quello della “grazia divina” e del “potere magico”, per cui può essere assimilata alla egizia Iside, la Signora della magia il cui nome si scrive in geroglifico con il simbolo del trono in quanto dispensatrice della regalità. Essa è la personificazione del potere femminile di cui parla Valeria alle donne romane per fermare Coriolano nella sua marcia contro la città: “[Noi donne ] possediamo una forza che non è posta nelle armi o nella forza delle mani, da questa ce ne esenta la natura, ma nella benevolenza e nella persuasione” (60). È il potere potenziale della Femmina che diviene potere in atto mediante l’azione del Maschio. La sua partecipazione ai due rituali dei Vinalia (61) nei quali Venere è unita a Giove, connessi all’uso magico e sacrale del vino quale sostituto del sangue dei sacrifici, costituiscono a nostro avviso l’espressione della religione di Roma nel simboleggiare in senso anagogico e non metaforico l’unione del Maschile e del Femminile.
- MARTE
Se Venere è figura del potere del Femminile (62), Marte è espressione del potere al maschile: Dio antico e comune a tutti i popoli latini, presso i quali, a quanto è dato sapere, si ritrovano sia il Flamen martialis che i sacerdoti Saliares che gli sono propri (63), egli è in origine aniconico, rappresentato da una lancia o da un giavellotto, e solo più tardi viene raffigurato con sembianze umane. Tutte le varianti del suo nome nelle diverse lingue latine (Mars, Mamers, Marmar) sono riportabili ad un Mauors- derivante a sua volta dalla radice indoeuropea *mar- da cui il sanscrito marikis, lucente (64), per cui Mars sarebbe “il Dio splendente”, quindi una divinità avente carattere solare e celeste, e d’altronde il Carmen Saliare gli attribuisce il tuono e lo chiama “Dio della luce” (65), titoli solitamente propri di una divinità uranica. Forse è per tale motivo che, come abbiamo suggerito in una nota precedente, uno dei rituali connessi all’uso sacrale del vino, i Meditrinal![]() ia, spetta a lui solo, rendendolo così pari a Giove. Marte è quindi una figura complessa, che si può ricostruire solo conside¬rando secondario l’aspetto meramente guerriero, che è divenuto il suo attributo principale a causa della interpretatio graeca come forma latina di Ares: Marte è una divinità celeste che esplica la sua attività sul mondo creato mediante il mantenimento dell’ordine, se neces¬sario anche con le armi, proteggendo l’esterno della città come i campi dei suoi cittadini, allontanando ciò che è male, i nemici umani ma anche le forze negative o comunque pericolose: “Tutta la sua funzione si esercita sulla periferia: indifferente alla na¬tura di ciò che la sua vigilanza protegge, egli è la sentinella che opera al limite, sulla frontiera, ed arresta il nemico” (66). Questo lo si vede chiaramente nel suo aspetto di custode dei confini dei campi e dei possedimenti dell’agricoltore nel sacrificio pri¬vato del suovetaurilia, funzione nella quale è chiamato a tenere lontane le intemperie e le malattie dai campi e dagli animali, non a garantirne la fecondità e la crescita, perché queste sono azioni richieste ad altre divinità esclusivamente agricole (67). Altra azione del Dio è la sua tutela sui giovani maschi, che vengono iniziati come guerrieri sotto la sua potestà e per tale motivo egli è anche la guida divina del ver sacrum, l’emigrazione dei giovani di una città nati nell’anno in cui un grave evento aveva turbato l’ordine della nazione: la consacra¬zione di un’intera generazione è posta sotto la sua vigilanza af¬finché giunga senza pericolo alla mèta che la volontà divina le ha assegnato e l’ordine venga così ricostituito.
ia, spetta a lui solo, rendendolo così pari a Giove. Marte è quindi una figura complessa, che si può ricostruire solo conside¬rando secondario l’aspetto meramente guerriero, che è divenuto il suo attributo principale a causa della interpretatio graeca come forma latina di Ares: Marte è una divinità celeste che esplica la sua attività sul mondo creato mediante il mantenimento dell’ordine, se neces¬sario anche con le armi, proteggendo l’esterno della città come i campi dei suoi cittadini, allontanando ciò che è male, i nemici umani ma anche le forze negative o comunque pericolose: “Tutta la sua funzione si esercita sulla periferia: indifferente alla na¬tura di ciò che la sua vigilanza protegge, egli è la sentinella che opera al limite, sulla frontiera, ed arresta il nemico” (66). Questo lo si vede chiaramente nel suo aspetto di custode dei confini dei campi e dei possedimenti dell’agricoltore nel sacrificio pri¬vato del suovetaurilia, funzione nella quale è chiamato a tenere lontane le intemperie e le malattie dai campi e dagli animali, non a garantirne la fecondità e la crescita, perché queste sono azioni richieste ad altre divinità esclusivamente agricole (67). Altra azione del Dio è la sua tutela sui giovani maschi, che vengono iniziati come guerrieri sotto la sua potestà e per tale motivo egli è anche la guida divina del ver sacrum, l’emigrazione dei giovani di una città nati nell’anno in cui un grave evento aveva turbato l’ordine della nazione: la consacra¬zione di un’intera generazione è posta sotto la sua vigilanza af¬finché giunga senza pericolo alla mèta che la volontà divina le ha assegnato e l’ordine venga così ricostituito.
Per riassumere quanto abbiamo detto potremmo definire (per quanto un Dio possa essere “definito”) Giano come il signore del “passare”, spirituale o materiale che sia, Saturno l’ordinatore della realtà, Vortumno il Dio del “mutare”, del fluire, del trasformare, Vulcano il “Fuoco”, forse da intendersi come “fuoco sotterraneo”, Vesta il “luogo” dove si manifesta il Fuoco sacro, potenzialità di creazione che genera rimanendo vergine con l’azione creatrice del Fuoco, Marte la “maschilità” che protegge e difende, Venere la “grazia” che l’uomo ottiene dagli Dèi, il punto di collegamento fra i due mondi, così come, per fare altri esempi, Apollo è il “medico”, colui che previene e ripara i danni che la creatura umana o l’insieme del popolo possono subire, Cerere il “luogo” dove ciò che muore si tramuta in nuova vita, che siano i semi dei cereali o gli Antenati.
IL SACERDOZIO A ROMA
Per completare queste note sugli Dèi di Roma dobbiamo brevemente accennare al rituale con cui si rendeva il dovuto onore agli Dèi, il che ci introduce a un discorso complesso sul sacerdozio: a Roma è possibile distinguere un culto privato, spettante alla singola gens o alla familia (sacra gentilicia) o al pater familias (sacra privata), da un culto pubblico (sacra publica) amministrato da specifiche classi sociali (si pensi ai rituali della parte femminile della societas quali quelli di Mater Matuta o di Bona Dèa), o dalla classe sacerdotale (68)(sacerdos da sacer unito alla radice *dhē, da cui il verbo facio) che agiva in nome e per conto della civitas e dei suoi cives.
I sacerdoti, cooptati dal collegium o dalla sodalitas in cui entravano a far parte (69), con la sola eccezione del Rex sacrorum, dei Flamines e delle Vestali che dovevano essere nominati direttamente dal Pontefice Massimo, e in origine tratti dalla classe patrizia, erano “quasi sempre organizzati in collegi o sodalitates, non costituivano una casta, né una classe; non godevano di particolari esoneri, ma al tempo stesso non essendo I'esercizio di una carica sacerdotale incompatibile con alcuna altra attività (tranne che nel caso del Flamen Dialis), potevano di norma continuare a svolgere la vita abituale di qualunque cittadino romano” (70), in particolare ricoprire cariche civili. Era loro richiesta la cittadinanza romana, l’irreprensibilità della condotta, l’integrità fisica e la nascita legittima da genitori liberi. “Quale che fosse la classe sociale di provenienza, a tutti erano richiesti determinati requisiti: la cittadinanza romana, la nascita legittima e l’integrità fisica e morale. I vari sacerdoti erano nominati per cooptazione all’interno dello stesso collegio, ad eccezione del Rex sacrorum, dei Flamini e delle Vestali, che venivano nominati direttamente dal Pontefice Massimo” (71).
Queste brevi considerazioni fanno comprendere come a Roma il rapporto tra uomo e sacro costituente la base dell’azione rituale non fosse appannaggio esclusivo di una classe distinta, come si ha ad esempio nelle religioni cosiddette abramitiche, Ebraismo, Cristianesimo e Islam, ma in qualche modo era pertinenza di tutto il popolo romano senza distinzione di sesso. I sacerdoti dovevano compiere un rito e il rito (da *rta, “misura”, iranico arta, “ordine cosmico che fonda la verità” 72), qualunque esso sia, cruento o incruento, è un’azione da compiere secondo norme rigorosamente codificate per mettere in contatto il sacerdote con la divinità, non in modo fittizio e allegorico ma reale, affinché sia stabilito e mantenuto in atto l’ordine della pax Deorum. Entrare in contatto con il Divino richiede una preparazione che si può ottenere solo attraverso l’esercizio di una via iniziatica e non semplicemente perché si ha l’etichetta di “sacerdote” incollata sulla toga. Un singolare esempio di come si debba intendere il rapporto che si viene a creare tra il sacerdote e il suo Dio lo possiamo leggere in queste parole scritte da una mistic![]() a cattolica contemporanea, Madre Trinidad della Santa Madre Iglesia (73): “Dove sono gli angeli per dare a Dio la gloria che gli dà il sacerdote di Cristo? Dov’è una creatura creata che sia innalzata alla dignità terribile di far scendere dai cieli il Dio vivo? Quando mai si è vista tutta la corte celeste, prostrata volto a terra in attesa sorprendente, adorare questo momento terribile in cui tu, sacerdote, pronunci su questo pezzetto di pane le parole di consacrazione e di vita che fanno correre qui rapido, davanti al tuo comando, lo stesso Dio intoccabile a introdursi in quell’ostia bianca per essere offerto da te all’immensità della Maestà divina?”.
a cattolica contemporanea, Madre Trinidad della Santa Madre Iglesia (73): “Dove sono gli angeli per dare a Dio la gloria che gli dà il sacerdote di Cristo? Dov’è una creatura creata che sia innalzata alla dignità terribile di far scendere dai cieli il Dio vivo? Quando mai si è vista tutta la corte celeste, prostrata volto a terra in attesa sorprendente, adorare questo momento terribile in cui tu, sacerdote, pronunci su questo pezzetto di pane le parole di consacrazione e di vita che fanno correre qui rapido, davanti al tuo comando, lo stesso Dio intoccabile a introdursi in quell’ostia bianca per essere offerto da te all’immensità della Maestà divina?”.
Se, come scrive “Rutilio”, ”I sacerdoti [pubblici] erano pubblici magistrati, cui non si chiedeva alcuna preparazione specifica, né li si sottoponeva a riti di iniziazione”(74), dobbiamo arguire che il neo sacerdote doveva essere già iniziato di per sé per poter gestire il rapporto con il sacro, e tale iniziazione gli poteva solo provenire da quanto aveva compiuto in precedenza, in altre parole si trattava dell’iniziazione cominciata nell’adolescenza e proseguita fino al periodo di giovane adulto quando, maschio o femmina che fosse, entrava a far parte della societas romana con quello che supponiamo fosse l’ultimo rito, il passaggio per il Tigillum sororium del mese di Ottobre, “luogo” del compimento dell’iter iniziatico dei giovani e delle giovani sotto la protezione di Janus Curiatius e di Juno Sororia (75). Ne deriva, poiché l’espletamento di un rito era compito sia dei sacerdoti pubblici sia dei privati, che a Roma fosse normale per tutti, o almeno per gran parte dei suoi cives sia maschi che femmine, la condizione iniziatica.
Note:
1 - Come abbiamo più volte sottolineato in altri lavori, il termine “mito” va inteso nel suo reale significato, non “fantasia”, accezione che viene data nell’àmbito della cultura moderna per ignoranza della sostanza delle parole, ma secondo la definizione di Attilio Mordini: “Il termine mythos significa, almeno nel senso originario, parola, parola che si manifesta dal silenzio nell’atto segreto dell’iniziazione ai Misteri; e cela, ma al tempo stesso porge discretamente e rivela, la verità che nel gran silenzio primordiale è racchiusa” (MORDINI Il Tempio del Cristianesimo, Vibo Valentia 1979, p. 10).
2 - GALIANO Vesta, il Fuoco di Roma, Roma 2011; Mars Pater, Roma 2014; Venere, la Grazia divina, Roma 2014; Diana e Apollo, la selva e l’Urbe, con M. Vigna, Roma 2015; Vulcano, il Fuoco sotterraneo (in preparazione).
3 - GALIANO e VIGNA Il tempo di Roma, Roma 2013.
4 - Camese per Macrobio è di sesso maschile, mentre per molti autori latini è una regina, divenuta successivamente moglie di Janus:
5 - MACROBIO Saturnalia I, 7, 19.
6 - CARANDINI (La nascita di Roma, Dèi. Lari. Eroi e uomini all’alba di una civiltà, Torino 1997, pp. 113–137) nel dare un inquadramento storico alle origini di Roma, pone nell’Età del Bronzo Medio (1750 – 1350 a.C.) il primo insediamento stabile sul Campidoglio, al quale corrisponderebbe, sempre secondo Carandini, un abitato analogo sul Gianicolo, del quale però ancora non è stata trovata traccia (probabilmente situato nella sua parte più alta, la zona di Porta San Pancrazio, in coincidenza dell’antico tracciato viario, attuale via Aurelia). È da notare che la cronologia presentata da Carandini corrisponde quasi perfettamente a quella stabilita centotrenta anni prima da Camillo Ravioli nel suo Pensieri e studi diversi, parte I: Cronologia primitiva, stampato a Roma nel 1862, cioè in un periodo nel quale le tecniche di ricerca e le conoscenze archeologiche del sito di Roma erano di gran lunga inferiori alle attuali.
7 - DUMÉZIL Jupiter Mars Quirinus, Torino 1955, ritiene che “la sua figura bifronte può essere l’utilizzazione acciden¬tale di un tipo plastico mediterraneo” (p. 341); non vi sono nelle tradizioni indoeuropee figure di Dèi bicipiti, salvo la Dèa Aditi la quale è detta “dai due volti” perché è posta all’inizio e alla fine di ogni sacrificio (DUMÉZIL La religione romana arcaica, Milano 1977p. 293).
8 - Così VARRONE secondo la citazione di Agostino in De civ Dèi VII, 9.
9 - MACROBIO Saturnalia I, 9, 11: “Janus da ire, perché il mondo va sempre muovendosi in cerchio e partendo da sé stesso a sé stesso ritorna”. Prima dell’affermarsi di questa tesi etimologica, Janus era fatto derivare da una radice *dei, *dia con significato di “brillare”, da cui sarebbero derivati (D)ianus, Di(vi)ana e Diana, tesi successivamente rigettata per motivi etimologici (D’ANNA Il Dio Giano, , Scandiano 1992, p. 23) e che si basava su di una affermazione di Nigidio Figulo riportata da MACROBIO Saturnalia I, 9, 8: “Nigidio dichiarò espressamente che Apollo è Giano e Diana è Giana, cioè Iana divenne Diana per l'aggiunta della lettera d che spesso viene premessa alla i per eufonia”.
10 - BAISTROCCHI Arcana Urbis, considerazioni su alcuni rituali arcaici di Roma, Genova 1987, p. 190; per il complesso argomento del significato di Giano e del suo rapporto con Vesta rimandiamo ad un’attenta lettura del capitolo V del testo di Bai¬strocchi pp. 188–248 e a GALIANO Il Fuoco di Vesta, Roma 2011.
11 - OVIDIO Fasti I, vv. 111-112.
12 - MACROBIO Saturnalia I, 9, 9–10.
13 - Per alcuni Saturno è un Dio non degli Aborigeni ma dei Siculi: Brex, nel suo Satur¬nia tellus, Roma 1944 p. 23, riporta l’etimologia stessa del nome dei Siculi alla sikala, il falcetto di Saturno.
14 - DI NARDO ne Il preistorico culto infero del Vulcano laziale, Velletri 1942, p. 33 dà un’interessante etimologia del nome:“Saturno (da Sat = il saturo, Ur = il fuoco), figlio del fuoco celeste Ur-an e di Vesta, il focolare terrestre” (sottolineature nel testo); identificando il Dio con il Vulcano Albano, vede nei tre figli che non furono divorati da Saturno (in realtà il mito è riferito al greco Kronos) le tre bocche fiammeggianti del vul-cano: “Vulcano-Summano (Giove infero), Nettuno-Tritone (il vulcano sorto dal mare, l’Enosigeo cioè lo scuotiterra) e Pluto (da pilum = pilastro) il Re dell’Ade, sinonimi del Saturno stesso nascosto o latente nel Lazio”.
15 - Per tale motivo Saturno era identificato con Sterculius o Stercutus, il cui nome deriva chiaramente dallo “sterco” come concime per i campi.
16 - VARRONE De lingua latina V, 64.
17 - MACROBIO Saturnalia I, 7, 25.
18 - MACROBIO Saturnalia I, 7, 27.
19 - Il Carmen Saliare chiama Janus con l'appellativo di Consivius, a indicare che, come “se¬minatore”, egli rappresentaù la causa prima della generazione.
20 - Che con Saturno abbia inizio la storia lo dimostrava secondo Macrobio Sat I, 8,4 la pre¬senza delle statue dei Tritoni sul frontone del suo tempio: “Sul frontone del tempio di Saturno furono posti dei Tritoni con trombe, perché dai suoi tempi ad oggi la storia è chiara e quasi parlante, mentre prima era muta, oscura e sconosciuta, come dimostrano le code dei Tritoni immerse nella terra e nascoste”. La connessione di Saturnus con i Tritoni è per noi un ulte¬riore simbolo della sua attività ordinatrice sulla creazione, raffigurata nel dominio del Dio sulle Acque simbolo della potenzialità generatrice; per questo i Romani lo consideravano il più grande degli Dèi, come scrive Macrobio Sat I, 7, 16: “Voi Romani celebrate Saturno con grandissimo onore, forse più di tutti gli altri dèi”.
21 - GELLIO Noctes atticae XIII, 23, 2. Così ne scrive DUMÉZIL La religione romana arcaica, Milano 1977, p. 347: “Anteriori ai libri dei Pontefici, tanto antiche che il loro significato risulta talvolta incerto, sono le Entità femminili che le ‘comprecationes Deum immortalium, quae ritu romano fiunt’ congiungono a numerose divinità importanti, delle quali esse esprimono, sotto un certo aspetto, una fondamentale modalità d’intervento [quella che noi chiamiamo “qualità”]: ‘Lua Saturni, Salacia Neptuni, Hora et Virites Quirini, Maia Volcani, Herie Junonis, Moles et Nerio Martis’. Il medesimo processo si nota anche nel rituale umbro di Iguvium (Tursa Çerfia)”.
22 - LIVIO Historiae VIII, 1: “Il Console Gaio Plauzio [sconfitti i Volsci]… diede le armi dei nemici a Lua Mater”.
23 - Ricordiamo che nei Saturnalia i servi prendevano il posto dei padroni ed era lecito il gioco d’azzardo, altrimenti severamente proibito per tutto il resto dell’anno.
24 - DEVOTO Nomi di divinità etrusche III: Vertumno, in “Studi Etruschi” n° 14, 1940, pagg. 275-280; FERRI Voltumna-Vertumnus, in Ou pan ephemeron. Scritti in memoria di Roberto Pretagostini (a cura di Braidotti, Dettori e Lanzillotta), vol. 2, Roma, 2009 pagg. 993-1009, pag. 994.
25 - Così Ovidio.
26 - Properzio: “Non m'allieto d'un tempio d'avorio, / è sufficiente per me poter vedere il Foro romano… / Tronco d’acero ero, frettolosamente sgrossato con la roncola, / un povero Dio nell’amata Urbe già prima di Numa”.
27 - Sempre Properzio: “Sono chiamato il dio Vertumno per la deviazione del fiume; / oppure poiché v'è l'uso di recarmi i primi frutti al mutare delle stagioni, / credete che da qui derivi il culto del Dio Vertumno…/ Tu, menzognera fama, mi nuoci; il significato del mio nome è diverso: / credi soltanto al Dio che parla di se stesso. / La mia natura è adatta ad assumere tutte le forme”.
28 - HARMON Religion in the latin Elegist, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt (a cura di TEMPORINI), Berlino-New York 1986, parte II vol. 16 pag. 1963.
29 - PROPERZIO Elegiae IV, 2: “Cingimi il capo di una mitra, ruberò la parvenza di Bacco,se però mi darai un plettro, la ruberò a Febo”.
30 - L’interessante etimo viene fatto notare da BETTINI Vertumnus: a God with no identity, in “I quaderni del Ramo d’Oro on-line” n° 3 (2010) pagg. 320-33, pag. 324.
31 - ORAZIO Sat II, 7, 24-25.
32 - Queste osservazioni su Vortumno sono basate sul lavoro di BETTINI Vertumnus cit.
33 - Per questo e per altri motivi l’etrusco Veltumna sembra aver mantenuto caratteri più arcaici rispetto al romano Vertumno, ormai quasi dimenticato a Roma.
34 - Notiamo come curiosità linguistica che la trasposizione del nome del Dio in quello del monte che erutta lava avviene in Italia nel Quattrocento e la prima citazione della parola “vulcano” nel significato attuale la si ritrova nella Hypnerotomachia Polyphili di Francesco Colonna del 1499, in cui il termine viene riferito all’Etna: “lo insaziabile vulcano Ethna”.
35 - CARANDINI La nascita di Roma cit. pag. 133 nota 27.
36 - VARRONE De lingua latina V, 10: “Ignis a gnascendo, quod huic nascitur et omne quod nascitur ignis succendit; ideo calet ut qui denascitur cum amittit ac friges Ab ignis iam maiore vi ac violentia Vulcano dictus. Ab eo quod ignis propter splendorem fulget, fulgur et fulmen, et fulguritum quod fulmine ictum”.
37 - SKEAT Etymological Dictionary of the English Language s.v. “Volcano”.
38 - Come scrive VARRONE De lingua latina V, 10, 74l’altare era dedicato a Summanus e a Vulcano: “Sono di lingua sabina le are votate e dedicate a Roma da Tito Tazio: come dicono gli annali, le votò a Ops, Flora, Vediovis e Saturnus, Sol, Luna, Volcanus e Summanus, Larunda, Terminus, Quirinus, Vortumnus, Lares e Diana Lucina”.
39 - COARELLI Il Foro Romano – età arcaica, Roma 1983, vol. I pp. 161–178.
40 - Si veda ad es. LIVIO Histotiae I, 37: “Tarquinio mandò a Roma bottino e prigionieri [cioè i Sabini sconfitti] e, dato fuoco alle spoglie nemiche secondo il voto che aveva fatto a Vulcano, continuò a spingere l’esercito nel territorio sabino”.
41 - DUMÉZIL La religione romana arcaica cit. pp. 284–285.
42 - CARDINI Alle radici della Cavalleria medievale, Firenze 1981 p. 55.
43 - Per Di Nardo e il vulcano Albano rimandiamo a GALIANO Roma prima di Roma, Roma 2016 (20111).
44 - FESTO: “Questo tipo di piccoli pesci veniva dato al Dio in sostituzione di anime umane” (in COARELLI Il Foro Romano cit. p. 163); vedi anche VACCAI Le feste di Roma antica, Roma 1986 (Roma 19271). p. 172 e nota 1 e SABBATUCCI La religione di Roma antica, Milano 1988, p. 199.
45 - CARANDINI La nascita cit. p. 518.
46 - OVIDIO Fasti, VI 295-296: “Esse diu stultus Vestae simulacri putavi / mox didici curvo nulla subesse tholo”.
47 - DUMÉZIL La religione cit. p 287 nota 16.
48 - Si tratta di una delle più antiche monetazioni romane (circa 225 a.C.), basata sui sottomultipli della libra, per cui è anche nota come serie “librale” (La moneta di Roma, a cura di CATALLI, Novara 2010, pp. 72-75), nella quale sono raffigurati in ordine discendente di valore monetale Giano, Saturno, Minerva, Ercole, Mercurio e Roma (non Bellona, come ritiene Dumézil, ibidem p. 192 nota 8).
49 GIANNELLI Il sacerdozio delle Vestali romane, Firenze 1913, p. 13 nota 1. Non ostante sia stato scritto ormai più di un secolo fa, il testo di Giannelli rimane molto interessante per il copioso materiale in esso contenuto.
50 - GIANNELLI Il sacerdozio cit. p. 27 e nota 6.
51 - DEVOTO Origini indoeuropee - Il lessico indoeuropeo, Firenze 1962, Tabelle, n° 441.
52 - Sul Fuoco sacro, sui rituali ad esso connessi nell’India vedica e il loro rapporto con Roma rimandiamo all’importante articolo di FILIPPANI RONCONI Agni-Ignis, metafisica del Fuoco sacro, in “La Cittadella” anno I, 2001, 4.
53 - Colui che aveva rapporti sessuali con una sacerdotessa vestale era accusato di incestum.
54 - BAISTROCCHI Arcana Urbis, considerazioni su alcuni rituali arcaici di Roma, cit. p. 190.
55 - DUMÉZIL Jupiter, Mars, Quirinus cit. pp. 342-349.
56 - Dumézil riporta tra le altre conferme della sua asserzione la serie delle divinità invocate nelle preghiere degli Atti dei Fratelli Arvali, alcuni passi di Ovidio e di Cicerone ed altre possibili concordanze, per cui si rimanda al luogo citato.
57 - MACROBIO Saturnalia I, 17, 42.
58 - VARRONE De lingua latina V, 10: “Non quod vincere velit Venus, sed vincire”.
59 - DUMÉZIL La religione cit. pp. 366–367.
60 - DIONISIO D’ALICARNASSO Storia di Roma arcaica VIII, 39, 2.
61 - Le offerte del vino vengono effettuate in due diversi momenti con la libazione rituale a Giove e a Venere nei Vinalia Priora del 23 Aprile e nei Vinalia Rustica o Posteriora del 19 Agosto, ai quali a nostro parere vanno aggiunte le Quinquatrus Minusculae del 15 Giugno dedicate al solo Giove e i Meditrinalia dell’11 Ottobre dedicati al solo Marte. Di questo abbiamo scritto in Marte e Giove: l’offerta del vino, pubblicato su Simmetria online nel 2014.
62 - Ovviamente Roma conosce molte e differenti espressioni del “potere femminile” che qui però non possiamo trattare: da Ops a Cerere, da Mater Matuta a Fortuna molteplici sono le forme che il “potere femminile” assume a Roma, a dimostrare, se ce ne fosse la necessità, come la sua religione ben sapesse che maschile e femminile sono due forme di espressione dell’unica Realtà superiore, che non possono prevaricare l’una sull’altra degenerando in uno stupido maschilismo o femminismo, deteriori e soprattutto inutili.
63 - Sono conosciuti a Tivoli i Saliares di Ercole, ma essendo Ercole non una divinità del commercio, come affermano gli autori moderni, ma un Dio guerriero come Marte; scrive infatti Macrobio: “Tale Dio anche presso i Pontefici è identificato con Marte” (Saturnalia III, 12, 5). Ercole va tenuto distinto dal greco Herakles, che è un semidio e non un Dio come Ercole: infatti il suo nome è composto con quello di un’altra divinità, “la gloria di Hera”, a significarne la dipendenza, il che non può essere concepibile per un Dio.
64 - LEWIS e SHORT Latin Dictionary, Oxford 1879, sub voce.
65 - Frammento 2 del Carmen Saliare: “Cume tonas, Leucesie, prae tet tremonti / quot ibet etinei deis cum tonarem”. Il testo, scritto in latino arcaico del IV sec. a.C., può essere approssimativamente così tradotto: “Quando tuoni, o Luminoso, davanti a te tremano / tutti gli Dèi che lassù ti hanno sentito tuo¬nare”.
66 - DUMÉZIL Jupiter Mars Quirinus cit. pag. 194.
67 - Ancora oggi la maggior parte degli Autori considera Marte una divinità agricola, pregiudizio al quale già si era opposto Dumézil in particolare in Jupiter Mars Quirinus cit.
68 - Numerosi i testi e i saggi che trattano dei sacerdozi e dei sodalizi romani a cui per brevità rimandiamo, ricordando, oltre gli articoli più avanti citati, i testi di HUBERT Antichità pubbliche romane e idem Antichità private romane, Milano 1986 (riedizione anastatica della traduzione del 1902, ma sempre valido), e di “CLAUDIO RUTILIO” Pax Deorum, Scandiano 1989 (prima edizione Messina 1983).
69 - Fino al 367 a. C., quando con la lex Licinia Sextia i viri sacris faciundis furono portati da due a dieci, metà dei quali plebei. In seguito dal 104 a. C. furono eletti nei comitia calata da 17 tribù scelte a sorte fra le 35 che componevano la societas romana (“RUTILIO” p. 45).
70 - SANTI I viri sacris faciundis, Atti del II incontro di studio del “Gruppo di contatto per lo studio delle religioni mediterranee”, Roma 10-11 Maggio 2005, p. 172.
71 - Sacerdotes publici populi romani quiritium, in “Acta Bimestria populi romani”, anno I n° VI, Aprile-Maggio 2011, pp. 19-20.
72 - DUMÉZIL La religione cit. p. 85.
73 - Madre Trinidad della Santa Madre Iglesia Il grande momento della Consacrazione, Città del Vaticano 2000, p. 7 (sottolineiamo: “con licenza ecclesiastica”).
74 - “CLAUDIO RUTILIO” Pax Deorum cit. p. 43.
75 - Di tale rito abbiamo scritto in GALIANO Il tempo di Roma, Roma 2013, pp.333-337.
Paolo Galiano
"Questo saggio è estratto con il permesso dell'autore da 'Almanacco scientifico n° 3 - Atti del Convegno Religione e religioni', pubblicato dalle edizioni Simmetria, Roma 2018"
L'articolo Gli Dèi e il Sacerdozio di Roma – Paolo Galiano© proviene da EreticaMente.


 Nella donne questo canale si trova a destra Infine Rasana, in tibetano Kyangma, a destra rosso (per le donne a sinistra). Nasce alla cima dell’ano corre parallelo al canale centrale, raggiunge la sommità della testa e si ripiega giù fino alla narice desta. E’ rosso perché trasporta i bindu rosso, Iantra del Guhyasamaja del Chakramsavara di Yamantaka descrivono il canali Kyangma e Roma paralleli al canale centrale .Nei due canali circolano i venti mentre nel canale centrale non circola nessun vento. Nel Kalachakra invece i canali destro e sinistro si incrociano al canale centrale al livello dell’ombelico contengono varie sostanze. Nella parte superiore il canale destro contiene il bindu rosso, il canale sinistro contiene il bindu bianco e il canale centrale vento. Nella parte inferiore il canale destro contiene le feci, il canale sinistro l’urina e il canale centrale il seme. La differenza sostanziale tra il Kalachakra e gli altri sistemi è che nel canale centrale non è vuoto ma circolano venti e contiene il seme. Kongtrul Rinpoche a questo proposito sostiene in un volume del tesoro della conoscenza dedicato ai Tantra che nei tre canali scorrono tre tipi di venti karmici il lunare, il solare e il Rahu. Vedremo i Venti karmaci e venti di saggezza nel prossimo articolo. Kongtrul Rinpoche è un Maestro Rime (nella sua biografia apprendiamo che era la sua prima formazione monastica era Bonpo) e soprattutto era un grande Maestro Dzogchen. La sua posizione riflette la posizione dello Dzogchen. A questo proposito Longchenpa i considera i canali sopra menzionati di essere il supporto alla visione Samsarica ma di essere comunque utili per fare delle esperienze precise dello stato naturale: infatti, benchè lo Dzogchen ritenga che i metodi Tantrici non siano in grado di trasformare i venti karmici in venti di saggezza, nei tre canali circolano delle forme di venti karmici menzionati da Kongtrul Rinpoche che se controllati possono essere il fondamento per il riconoscimento della propria vera natura al di là di ogni dubbio. Le volte scorse avevamo già visto che l’esperienza della natura poteva avvenire anche nel contesto ordinario, solo che in questo contesto sarà molto fugace questa esperienza dello stato naturale sarà molto più chiara e priva di dubbi. Ad ogni modo fintanto che nel nostro corpo predomineranno i venti karmici le esperienze non potranno che essere momentanea ed instabili .Abbiamo già parlato dei tre tipi di rigpa e del SamrigRigpa o l’esperienza del rigpa della mente in movimento, finchè non applicheremo i metodi del Thodgal non saremo mai in grado di far dissolvere i venti Karmici e la visione illusoria non ci apparirà come tale .Il Thodgal porta alla dissoluzione dei venti karmici nei venti di saggezza che scorrono in determinati canali.
Nella donne questo canale si trova a destra Infine Rasana, in tibetano Kyangma, a destra rosso (per le donne a sinistra). Nasce alla cima dell’ano corre parallelo al canale centrale, raggiunge la sommità della testa e si ripiega giù fino alla narice desta. E’ rosso perché trasporta i bindu rosso, Iantra del Guhyasamaja del Chakramsavara di Yamantaka descrivono il canali Kyangma e Roma paralleli al canale centrale .Nei due canali circolano i venti mentre nel canale centrale non circola nessun vento. Nel Kalachakra invece i canali destro e sinistro si incrociano al canale centrale al livello dell’ombelico contengono varie sostanze. Nella parte superiore il canale destro contiene il bindu rosso, il canale sinistro contiene il bindu bianco e il canale centrale vento. Nella parte inferiore il canale destro contiene le feci, il canale sinistro l’urina e il canale centrale il seme. La differenza sostanziale tra il Kalachakra e gli altri sistemi è che nel canale centrale non è vuoto ma circolano venti e contiene il seme. Kongtrul Rinpoche a questo proposito sostiene in un volume del tesoro della conoscenza dedicato ai Tantra che nei tre canali scorrono tre tipi di venti karmici il lunare, il solare e il Rahu. Vedremo i Venti karmaci e venti di saggezza nel prossimo articolo. Kongtrul Rinpoche è un Maestro Rime (nella sua biografia apprendiamo che era la sua prima formazione monastica era Bonpo) e soprattutto era un grande Maestro Dzogchen. La sua posizione riflette la posizione dello Dzogchen. A questo proposito Longchenpa i considera i canali sopra menzionati di essere il supporto alla visione Samsarica ma di essere comunque utili per fare delle esperienze precise dello stato naturale: infatti, benchè lo Dzogchen ritenga che i metodi Tantrici non siano in grado di trasformare i venti karmici in venti di saggezza, nei tre canali circolano delle forme di venti karmici menzionati da Kongtrul Rinpoche che se controllati possono essere il fondamento per il riconoscimento della propria vera natura al di là di ogni dubbio. Le volte scorse avevamo già visto che l’esperienza della natura poteva avvenire anche nel contesto ordinario, solo che in questo contesto sarà molto fugace questa esperienza dello stato naturale sarà molto più chiara e priva di dubbi. Ad ogni modo fintanto che nel nostro corpo predomineranno i venti karmici le esperienze non potranno che essere momentanea ed instabili .Abbiamo già parlato dei tre tipi di rigpa e del SamrigRigpa o l’esperienza del rigpa della mente in movimento, finchè non applicheremo i metodi del Thodgal non saremo mai in grado di far dissolvere i venti Karmici e la visione illusoria non ci apparirà come tale .Il Thodgal porta alla dissoluzione dei venti karmici nei venti di saggezza che scorrono in determinati canali.