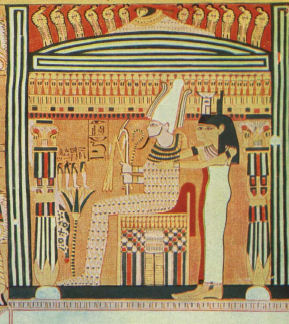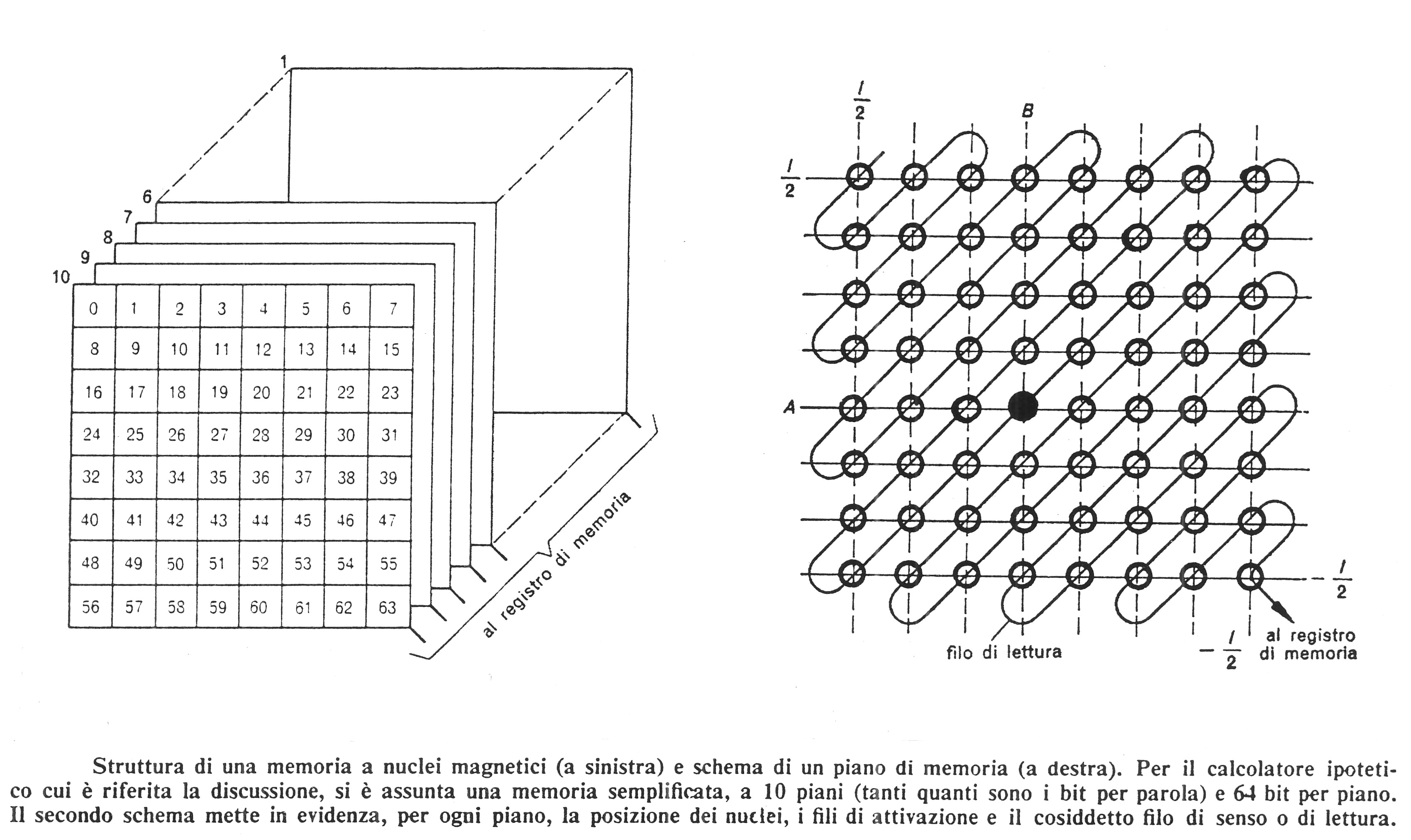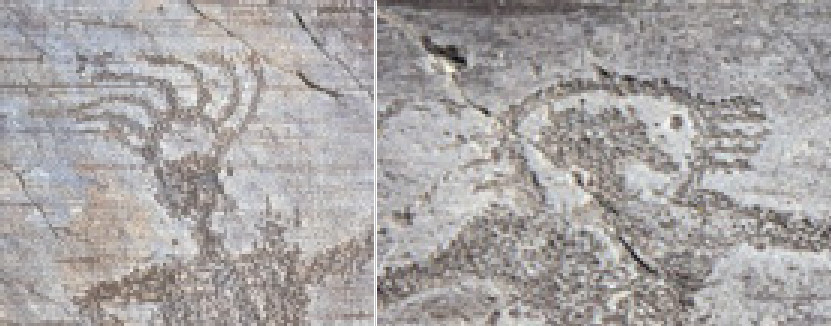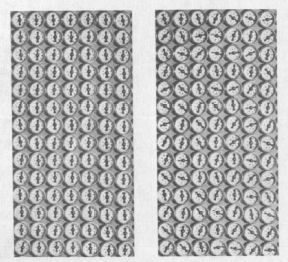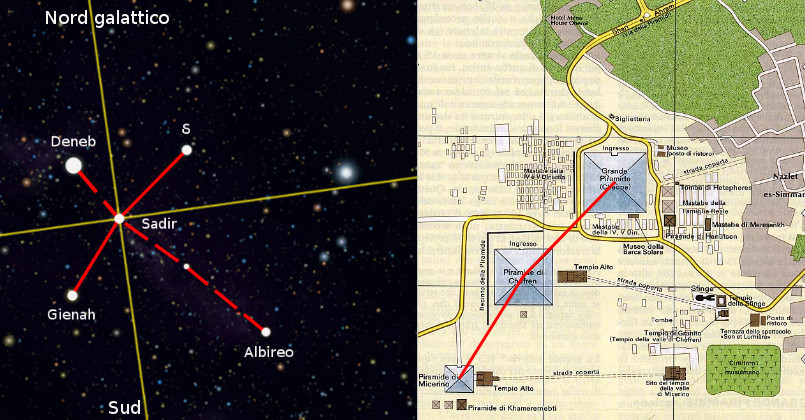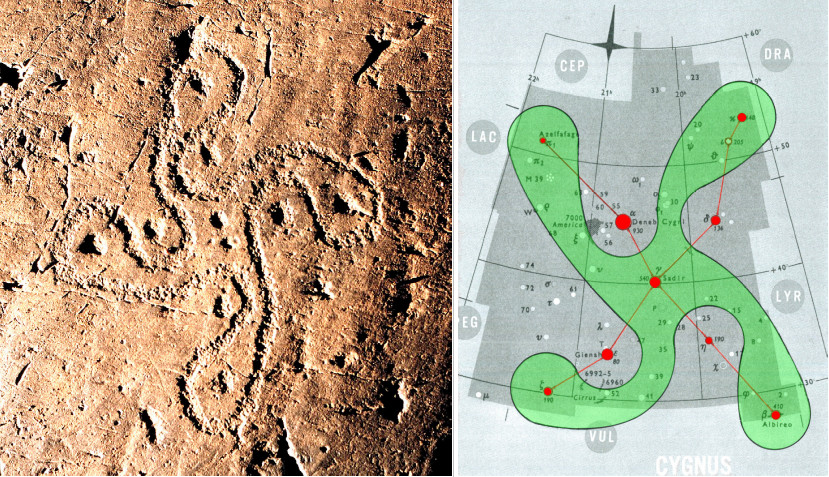![]()
Come leggiamo nei nostri manuali scolastici (1), il grande scontro tra l’offensiva protestante e la controffensiva cattolica è accompagnato dal dilagare di un fenomeno che, per le sue dimensioni e caratteristiche, è diventato quasi il simbolo di un’epoca: la caccia alle streghe. Migliaia di persone in tutta Europa vennero condannate a morte per stregoneria, soprattutto tra il 1550 e il 1650 circa: un periodo che, paradossalmente, coincide con l’estrema fioritura del Rinascimento e con la fase montante della rivoluzione scientifica. Cerchiamo di capire qualcosa di più su questo fenomeno, rispondendo a queste domande:![]()
1) Cosa si credeva esattamente sulle streghe e sul loro operato? Analizzeremo queste credenze, evidenziando quelle che sono rimaste vive ancora oggi nel folklore e nella cultura popolare;
2) Come operavano gli inquisitori? Leggeremo alcuni brani del manuale per cacciatori di streghe per eccellenza, il Malleus Maleficarum, che venne pubblicato nel 1486 e che fu un vero e proprio “best-seller”; da esso trarremo inoltre informazioni sulla concezione della donna in quell’epoca;
3) Come si svolgeva il processo? Metteremo a confronto le indicazioni riportate nel Malleus con quelle scritte in un manuale più tardo, l’Instructio pro formandis processibus in causis strigum, sortilegiorum et maleficiorum, del 1620, e vedremo come la procedura era cambiata nel segno di una maggiore cautela;
4) Come operava l’Inquisizione romana? Dagli studi più recenti sono emerse delle caratteristiche che la distinguono nettamente rispetto ai tribunali che operavano in altre zone d’Europa, in Germania, per esempio. Scopriremo come uno dei sacramenti che assumiamo anche noi oggi, la confessione, sia stato uno dei principali strumenti d’indagine per quel tribunale.
- La società del le streghe come società segreta
La credenza nella stregoneria e la conseguente persecuzione delle streghe, senza dubbio uno dei fenomeni più inquietanti della vita europea, non riguarda soltanto il periodo compreso tra la metà del XVI e la metà del XVII secolo, come si dice solitamente (periodo in cui in realtà toccò il suo acme), ma si colloca già prima, nel XV, e dura fino al XVIII secolo. Notizie sulle scorribande notturne di certe compagnie di donne e sugli scopi cui esse miravano sono reperibili in realtà già negli scritti dei canonisti medievali dal secolo X al XII; ma è alla fine del XII secolo e ai primi anni del XIII che risale il consolidamento di talune credenze nell’opinione popolare e il caratterizzarsi di specifici motivi stregonici. La ricerca sulla stregoneria, quindi, pone come termine a quo il secolo XIII. Tuttavia, le fonti dirette per lo studio della stregoneria moderna, abbondanti per il secolo XVI e i successivi, sono molto scarse per il XIV e non abbondano nella prima metà del XV. Nella stregoneria moderna confluiscono due credenze: quella nelle striges, note già nell’antichità classica, e l’altra, di età medievale, nella “società di Diana o di Erodiade”. Tra le credenze e i culti pagani che durarono per tutto il Medioevo e, proscritti dalla Chiesa, si rifugiarono nella magia e nell’astrologia, il culto di Diana ebbe un posto preminente. Identificata con la luna, essa amava per sua natura la notte e nello stesso tempo incarnava una delle forme di Ecate, la dea della magia, adorata con riti misteriosi. Nel suo culto avevano importanza grandissima i rettili e gli animali immondi, i filtri, le composizioni disgustose e le formule magiche. Gli antichi credevano che Ecate apparisse di notte al pallido lume della luna, insieme con la schiera delle sue donne, anime di morti senza pace, e che comparisse ai quadrivi delle strade; di qui l’idea che ai quadrivi si corresse soprattutto il rischio di incontrare il diavolo o coloro che avevano rapporti con esso. Quest’idea è documentata ancora nell’Italia dell’‘800: dalle ricerche di Placucci (tra i precursori dello studio scientifico del folklore), che condusse un’inchiesta, dietro richiesta ufficiale napoleonica, sui costumi e le credenze delle popolazioni soggette, pubblicata nel 1818 con il titolo Usi e costumi de’ contadini di Romagna, risulta tra le altre la credenza che, se si sta fermi in mezzo a un crocevia nella notte di San Giovanni Battista, tenendo il collo appoggiato a un forcone, si vedranno passare le streghe.
Al posto di Diana si può trovare anche Erodiade, la figlia di Erode (il suo vero nome è Salomè), che aveva chiesto a Erode la testa del Battista, e per questo era stata condannata a vagare col Maligno. Forse di qui deriva il legame tra le streghe e la notte di San Giovanni, di cui si è detto sopra e che compare in altre credenze vive ancora in età contemporanea, come l’idea che abbiano una maggiore inclinazione a diventare streghe le bambine nate nella notte di Natale o, appunto, in quella di San Giovanni (il 24 giugno). Dall’esame delle fonti medievali risulta che la Chiesa, benché ravvisasse diavoli nella figura di Diana e di Erodiade, e chiamasse seguaci di Satana coloro che all’una o all’altra si accompagnavano, si limitava a ritenere quelle credenze illusioni ispirate dal demonio e minacciava soltanto pene spirituali; il popolo inoltre credeva che le seguaci non avessero scopi criminali nelle loro scorrerie notturne, e si limitassero a entrare nelle case per curiosare dentro le pentole o le botti, in cerca di mense ben imbandite. Dai processi svoltisi tra il 1300 e il 1500, compare una concezione più articolata sulle streghe e sul loro operato. Le donne che venivano processate e torturate affinché confessassero, si rifacevano nelle loro deposizioni a quello che comunemente si diceva sulle streghe. Vediamo come rispondevano a domande come le seguenti:
Come si diventa streghe?
1. Occorre trovare una strega bene addestrata, una “maestra strega” e, entrata nelle sue grazie, prometterle di esserle fedele compagna nell’arte della stregoneria. Nei processi di metà XVII secolo si afferma che può essere una strega a condannare una ragazza alla stregoneria marchiandola con un sigillo sulla spalla sinistra (che gli inquisitori cercavano come segno inequivocabile);
2. la maestra bagna con la saliva le labbra della ragazza, e le ordina di andare al fonte dove ha ricevuto il Battesimo e dire che rinuncia all’autorità e alle leggi date da Dio e dalla Chiesa;
3. l’iniziata deve battere il capo tre volte contro il fonte e chiamare il diavolo con gli appellativi di signore e padrone, invocando il suo aiuto fino alla morte;
4. deve tornare dalla maestra strega, la quale le unge le tempie e le palme delle mani con un unguento preparato con il cadavere di un bambino nato morto o morto senza battesimo e, evocato il diavolo, le fa ripetere l’apostasia, cioè la rinuncia alla propria religione;
5. le due si recano in volo a Benevento, dove c’è un noce indicato come luogo per le riunioni delle streghe, e qui l’unguento viene benedetto dal diavolo; 6. viene invocato Maometto, il capo delle streghe, che compare con l’aspetto di un uomo bello e vestito di nero, con cui giocano e si divertono, fanno canti e balli; alle riunioni possono partecipare anche altri diavoli, che portano tutti nomi che non siano di Santi, come Cesare, Filippo ecc.![]()
Queste riunioni sono chiamate sabba. Per alcuni studiosi questo termine deriva dall’ebraico sabbath, il sabato, che era considerato, come altre usanze semitiche, l’origine di tutte le perversioni; per altri, da sabae, capre, l’animale maledetto in cui si incarnava il demonio, o sotto la cui pelle si nascondevano le baccanti, durante i riti orgiastici. Secondo la tesi di Murray (2) “sabba” risalirebbe al verbo s’esbattre, divertirsi: sabba come festa, rave di popolo per gioire, mangiare, divertirsi.
Come sono organizzate?
Le streghe sono così organizzate: sono raccolte in tante squadre, secondo i luoghi di provenienza, e ciascuna squadra è comandata da una strega-capitano o “patrona”, a cui sono affidate 20, 25 o anche 30 o 40 “scolare”. La strega-capitano resta in carica tre anni, allo scadere dei quali è confermata o sostituita, e l’elezione avviene sempre al noce di Benevento. Comandante supremo di tutte le squadre è la “regina”, cioè la “patrona maggiore”, quella che governa tutte le streghe. Almeno una volta durante il triennio del loro ufficio, le “patrone” devono andare a visitarla: si devono recare da lei nel mese di marzo, camminando a piedi di giorno e di notte, e la visita deve essere fatta rinunciando a un’importante faccenda. A sua volta, la regina ha il compito di assegnare alle streghe comandanti il territorio dove dovranno svolgere la loro attività, oltre a insegnare l’arte della stregoneria, e le “scolare” che saranno ai loro ordini.
Cosa fanno le streghe?
Producono unguenti o polveri capaci di far ammalare, impazzire o morire coloro a cui vogliono nuocere. Di notte, possono entrare nelle case: il diavolo sceglie le case dove ci sono lattanti e apre le porte alle streghe. Queste si portano appresso una gatta nera, nata in marzo; le streghe prendono le sue sembianze per entrare nella casa (di qui deriverebbe l’interpretazione di segno infausto che si dà comunemente se un gatto nero ci attraversa la strada), per controllare che le persone dormano e per spegnere eventuali lumi; quando la via è libera, la gatta torna dalla strega e le monta sulle spalle. Allora la strega trova il bambino, e prende a succhiargli il sangue dal naso, dalle orecchie e dall’ombelico; il sangue che non ingoia, lo ripone in un bossolo, poiché le potrà essere utile per la preparazione di pozioni. Oltre che agli esseri umani, le streghe possono nuocere al raccolto agricolo – perché sanno agire sugli eventi atmosferici, provocando temporali, grandine ecc. che possono avere effetti disastrosi – oppure al bestiame, sottraendo il latte alle mucche per esempio, o rendendo sterili le femmine. Si comprende quindi come le streghe fossero considerate un potenziale nemico per l’intera società del tempo, potendo colpire con i loro malefici quelle che erano le principali fonti di reddito per le comunità.
Cosa protegge dalle streghe?
Se davanti al lume arde un’immagine di Gesù o della Madonna; se in casa c’è un campanello; se c’è una chiesa vicino all’abitazione; se ai letti o alle pareti sono attaccate croci di foglie di palma o rami d’ulivo o pane benedetto, si può dormire sonni tranquilli.
Queste credenze sono durate a lungo, tanto che, soprattutto nella gente di campagna, persistono ancora molto vive le stesse idee sulle streghe che troviamo documentate negli atti dei processi e nella letteratura demonologia. Le streghe colpiscono ancora soprattutto i bambini e gli animali da lavoro, e sono responsabili delle perturbazioni atmosferiche. Rispetto alle credenze diffuse nei secoli precedenti, spiccano alcuni elementi:
- il forcone: è strumento per individuare le streghe (come si è detto, nella notte di San Giovanni Battista, si deve star fermi in mezzo a un crocevia, appoggiando il collo a un forcone: si vedranno passare le streghe) e allo stesso tempo per difendersi da esse (collocare sotto il letto un forcone, prima di coricarsi, rende inefficaci le loro arti;
- il sale: come spiega Jean Bodin (Demonomania, II, 2), il sale è elemento di purezza, perché «non si corrompe, né putrefà giammai e conserva le cose da corruttione e putrefattione, e il diavolo non cerca se non la corruttione e dissolutione delle creature come Iddio la generatione». Si crede inoltre che nei sabba che si tengono sotto il noce di Benevento, vengono imbanditi lauti banchetti, dove però tutte le vivande mancano di sale. Un poemetto ottocentesco in ottave, edito a Napoli, Storia della famosa Noce di Benevento, di un anonimo, narra, tra l’altro, che un contadino che aveva seguito la moglie al banchetto beneventano, accortosi che i cibi erano insipidi, aveva chiesto del sale; ciò finì col procurare la morte sua e della moglie.
Da recenti ricerche svolte a Benevento risulta che il popolo crede ancora che le streghe vadano alla riunione a cavalcioni di una scopa, e da lì passino nelle case a “sturpià peccerille e peccerelle”, dicendo le magiche parole: “Sotto l’acqua e sott’u vientu, sott’a noce ‘e Beneviento”. Nella parte subappenninica della provincia di Foggia l’antica formula magica è diventata un modo di dire. Infatti, di coloro che sfidano l’inclemenza del tempo e non hanno paura di camminare per la campagna la notte, la gente dice: “Sott’ a iacqu’ e sott’ a vent’ a noce de Bunevent”. In Sicilia si crede che ogni noce, non solo a Benevento, ma anche nell’isola, sia luogo di convegno delle streghe, tanto che è diventato proverbio che la noce fa male: “nuci, noci”. Credenze analoghe si trovano in tutt’Italia, non solo al Sud, ma anche nel Vicentino, e nei territori di Bergamo e Brescia. Le regioni italiane che ancora oggi conservano le più vive credenze sulle streghe sono le zone di montagna delle antiche diocesi di Como e di Trento, dove molte località portano ancora nomi che ricordano i congressi notturni (es: “Val de le stries” in Val Gardena, “Sas di stria” in Ampezzo). Nel Trentino si distinguono ancora oggi tre categorie di streghe: le nate streghe, votate al diavolo prima della nascita, nel qual caso recano un segno diabolico (una macchia scura) in qualche parte del corpo; le streghe inconsapevoli, toccate da qualche strega prima che siano battezzate; le streghe volontarie, quelle che in età matura si sono date al diavolo sapendo quel che facevano. Riguardo al primo gruppo, è credenza che siano fatalmente streghe quelle nate la notte di San Giovanni o la notte di Natale a mezzanotte; quest’ultima è creduta nel Veneto la notte preferita dalle streghe per insegnare ad altre persone incantesimi e sortilegi, perché i giorni santi sono i più adatti a offendere il Signore.
- Il Malleus maleficarum e la concezione della donna
È il 1484 quando papa Innocenzo VIII promulga la bolla Summis desiderantes in cui la stregoneria viene indicata come forma di eresia, e con cui il pontefice dà l’avallo alla caccia alle streghe. Due anni dopo, due inviati del pontefice, i domenicani Jacob Sprenger e Heinrich Institor, pubblicano il Malleus Maleficarum, che diventerà il testo ufficiale dell’Inquisizione sulla stregoneria, uniformando per tre secoli il rito di centinaia di processi. Il Malleus spiega prima di tutto perché sono le donne le più colpite dalla stregoneria e da Satana. Esiste una ragione “naturale”: la struttura fisica difettosa. La donna infatti è stata creata da Dio a partire dalla costola dell’uomo che è curva e storta. Imperfetta per natura, quindi, la donna deve per forza di cose recare danni al genere umano. A riprova dell’imperfezione femminile, il Malleus riporta il seguente aneddoto: la moglie di un tizio era annegata in un fiume e non si riusciva a ritrovarne il corpo; il marito fu visto mentre lo cercava risalendo la corrente. Alla gente che gli chiedeva perché la cercasse in senso contrario al fiume, egli rispose: «Questa donna in vita fece sempre l’esatto contrario delle mie parole. Ora la cerco all’inverso, perché è probabile che anche dopo morta sia andata all’opposto del consueto». Il fatto è che il male sta nel nome stesso della donna:
Femina dicitur a fe et minus, quia semper minorem habet et servat fidem… Mala ergo mulier ex natura cum citius in fide dubitat, etiam citius fidem abnegat, quod est fundamentum in maleficiis.![]()
Questa etimologia, assolutamente fantastica, si ritrova nel quarto libro dell’Acerba di Cecco d’Ascoli in un’invettiva contro le donne; non sappiamo se sia Cecco l’autore di questa etimologia, ma sappiamo che trasse non poco dalle enciclopedie medievali per la compilazione dell’opera, che rispecchia lo stato del sapere comune dell’epoca. Il diavolo fece peccare Eva ed Eva sedusse Adamo, che quindi fu indotto al peccato da lei e non dal diavolo: da ciò si deduce che la donna è peggiore del diavolo e più amara della morte. Poiché le streghe sottoscrivono patti espressi o taciti col demonio, a contrario degli eretici (i quali però sono i più inclini e idonei a prestare giuramento a Satana), l’eresia delle streghe giunge al più alto livello di malizia. Il nome stesso di “maleficae” rivela la vera natura delle streghe: «maleficae dictae sunt a male de fide sentiendo». Le streghe dunque hanno cattive opinioni della fede, per questo sono anche eretiche e la loro colpa è doppiamente grave. I due autori riepilogano le ragioni che spingono la donna verso la stregoneria: la donna è più credula e più inesperta dell’uomo; è più curiosa; il suo temperamento è più impressionabile; è più cattiva; è più portata a vendicarsi; cade più spesso nella disperazione; infine, è più loquace, e se una delle sue amiche è strega, fa presto a dirlo alle altre.
Sprenger e Institor si chiedono poi se le streghe siano sorte solo in tempi moderni. Esse sono sempre esistite, tuttavia nell’antichità erano i diavoli che possedevano le donne contro la loro volontà: esse erano quindi maleficiatae, non maleficae, cioè erano vittime del diavolo e non potevano nuocere a nessuno fuorché a se stesse. Invece, nei tempi moderni, le donne, per la cattiveria dell’animo e la dissolutezza dei costumi, desiderano e cercano il demonio: la stregoneria del XV secolo, concludono gli autori, ha appestato il mondo come una terribile malattia.
L’antifemminismo dello Sprenger e dell’Institoris è un fenomeno del tempo, sorto da una realtà sociale, più che da un tema letterario o da un pregiudizio religioso. Non è una caratteristica esclusiva della fine del Medioevo. In Sant’Agostino, in Ugo da San Vittore, la cui autorità fu grande in tutto il Medioevo, in Pietro Lombardo, i cui Libri sententiarum (del 1150 circa) furono il testo teologico più diffuso, in San Tommaso, la donna rappresenta la parte inferiore dell’umanità e l’uomo la parte superiore. Le invettive contro le donne sono un genere diffusissimo nella letteratura medievale. Al principio del XIII secolo i vizi e i difetti del carattere femminile erano stati enumerati in una lunga serie di proverbi volgari, che portano il titolo latino di Proverbia quae dicuntur super natura feminarum. Il culmine dell’antifemminismo è rappresentato da un’opera attribuita a Andrea Cappellano (principio XIII secolo) che raccoglie in una summa tutte le invettive antifemministe del Medioevo. Come si spiega tale odio verso la donna? Secondo il Novati, tali sentimenti non sono che la naturale, spontanea conseguenza dell’aborrimento per la vita mondana: chi mirava al distacco assoluto dalle cose terrene trovava nella donna il più grave degli ostacoli e in essa rappresentati tutti i più forti legami che avvincono l’uomo alla vita: l’amore, il matrimonio, la famiglia. In un codice del XIII sec., un poemetto inizia così:
Si Christum queris, vultum fuge mulieris.
3. La procedura inquisitoria dal Malleus (1486) all’ Instructio (1620)
Come si è detto, il Malleus maleficarum costituì un vero e proprio manuale per gli inquisitori: esso forniva indicazioni precise per tutte le fasi del processo, dalla denuncia alla condanna. Prima di iniziare il processo, gli inquisitori devono prendere delle precauzioni: non farsi toccare dalle streghe, evitare il primo sguardo delle accusate, portare addosso sale esorcizzato nella Domenica delle Palme ed erbe benedette. Il processo si apre in seguito ad accusa, a denuncia o per inquisizione d’ufficio. Quest’ultimo modo ha inizio facendo affiggere alle porte della chiesa una citazione generale, in cui la commissione inquirente ordina che, entro un certo numero di giorni, tutti coloro che abbiano notizie di stregoneria presentino le loro denunce e i loro sospetti, minacciando ai contravventori pene ecclesiastiche e temporali. Si ascoltano quindi le denunce e bastano due testimoni a giustificare l’avvio del processo. Possono essere assunti come testimoni contro l’imputata, mai in sua difesa, anche eretici, scomunicati, infami, spergiuri, assassini; si fa eccezione per i suoi nemici dichiarati, ma sono tali e tante le cautele che il giudice deve usare prima di riconoscere in una persona un nemico dell’imputata, che questa eccezione è quasi svuotata di significato. Procedendo contro un’accusata, il giudice deve badare a tre cose: alla fama di lei, agli indizi o all’evidenza del fatto, agli interrogatori dei testimoni. Circa gli indizi, ogni cosa era ritenuta buona: se l’accusata conduceva una vita irregolare, era indizio di rapporti col Maligno; se era di condotta irreprensibile, allora cercava di nascondere la sua cattiveria sotto il manto della bontà; se all’arrivo dell’inquisitore si allontanava da casa sua, si aveva l’indizio della fuga; se restava, era segno che il diavolo le aveva impedito di fuggire. Quando tutti e tre gli elementi concorrono contro l’accusata, si dà inizio al processo, che va trattato – come gli autori avvertono più volte – sommariamente (simpliciter et de plano). Al momento dell’arresto, la casa dell’accusata deve essere perquisita in ogni angolo con la massima diligenza, e devono essere arrestate anche compagne o serve con lei, perché si presume che ne conoscano i segreti. È opportuno sollevarla da terra, mettendola per esempio su una lettiga di giunchi: le confessioni rese nei processi e l’esperienza dei giudici testimoniano che le streghe, catturate in questo modo, non possono trarre vantaggio dal cosiddetto maleficium taciturnitatis, il maleficio del silenzio che il diavolo usa per evitare che le streghe confessino. L’imputata può indicare un difensore, ma non è detto che il giudice le assegni la persona da lei indicata; inoltre l’accusata non ha il diritto di conoscere i nomi dei testimoni. Se il difensore insiste, ed è gradito ai giudici, gli si possono palesare, ma con alcune “cautele”: per esempio, gli si dà l’elenco dei nomi dei testimoni e separatamente la copia delle deposizioni, badando o che la serie dei nomi non corrisponda all’ordine delle deposizioni, o che gli atti contengano circostanze non deposte. E poiché l’elenco dei testimoni viene richiesto per opporre contro alcuni o tutti l’eccezione della “inimicizia capitale”, il giudice potrà chiedere all’imputata, sin dal primo interrogatorio, se abbia nemici di tal fatta; e siccome di solito la risposta è negativa, dopo di ciò l’imputata non potrà più sollevare quell’eccezione, né potrà sollevarla il suo difensore. Durante l’interrogatorio, l’accusata può confessare subito la sua colpa, e in tal caso il processo è brevissimo, oppure può negare tutto, e allora bisogna ottenere la confessione a tutti i costi. Prima cercano di convincerla il giudice o persone di sua fiducia, anche promettendole la grazia; se ciò non basta, si passa alla tortura, che ha il principale scopo di allontanare il diavolo che può aiutare la strega a non sentire il dolore e a non confessare. Erano vari i sortilegi per non sentire dolore: si poteva bere una certa pietra, la menfite, tritata nell’acqua o nel vino; oppure il latte di una madre e di una figlia mescolato insieme, o mangiare focacce impastate con quel latte; oppure ancora inghiottire del sapone sciolto nell’acqua. ![]() C’erano infine delle formule da pronunciare prima di essere torturate, tratte per lo più dalla Bibbia o dai Vangeli e opportunamente modificate. Queste formule potevano essere scritte su dei bigliettini che le streghe potevano nascondere tra i capelli; per questo, i giudici potevano farle radere totalmente. Se la donna moriva durante la tortura, lo Sprenger e l’Institoris scagionavano completamente il tribunale, gettando tutta la colpa addosso al diavolo: Satana si era ripreso la preda, e se questa è stata degna di tanto favore, il motivo è che aveva commesso enormi delitti. Il più delle volte la condanna si risolve nella pena di morte.
C’erano infine delle formule da pronunciare prima di essere torturate, tratte per lo più dalla Bibbia o dai Vangeli e opportunamente modificate. Queste formule potevano essere scritte su dei bigliettini che le streghe potevano nascondere tra i capelli; per questo, i giudici potevano farle radere totalmente. Se la donna moriva durante la tortura, lo Sprenger e l’Institoris scagionavano completamente il tribunale, gettando tutta la colpa addosso al diavolo: Satana si era ripreso la preda, e se questa è stata degna di tanto favore, il motivo è che aveva commesso enormi delitti. Il più delle volte la condanna si risolve nella pena di morte.
Nel 1620 viene compilata una Instructio pro formandis processibus in causi strigum, sortilegiorum et maleficiorum del Sant’Uffizio, che condanna la procedura corrente per le streghe e gli stregoni, prendendo le mosse dai continui errori commessi dagli inquisitori nei processi. Vediamo quali sono questi errori e quali indicazioni fornisce l’Instructio.
L’errore principale e peculiare di quasi tutti i giudici è di passare all’inquisizione, alla carcerazione, e spesso anche alla tortura, senza prove sufficienti contro gli accusati. Nel caso di un malato o di un morto per maleficio va usata ogni accortezza nell’interrogare il medico che l’ha curato, e poi si deve richiedere il parere di un medico più dotto ed esperto. Se i medici hanno giudicato che c’è stato o può esserci stato un maleficio, il giudice può istruire il processo. Le donne carcerate per maleficio siano tenute in celle separate, perché spesso si sono trovate molte che hanno detto il falso contro se stesse in fatto di apostasia, credendo di uscire più presto dal carcere. Non sia consentito ai carcerieri o a chiunque altro di suggerire alle donne quello che dovranno dire al giudice, perché si è visto che così istruite hanno confessato cose che neppure si sono sognate. Si proceda subito dopo l’arresto a un’attenta perquisizione della casa della carcerata e si ordini il sequestro della roba sospetta (olio in vasetti, grasso, polveri ecc.), che sarà affidata ai periti onde accertare se può servire a uno scopo che non sia quello malefico. Si prelevino pure gli oggetti che possono giovare all’inquisito, come immagini sante, libri di preghiere, palme benedette ecc. Spesso accade che i familiari del malato, pensando a un maleficio, trovino strani gomitoli nei materassi del loro congiunto e corrano a portarli al giudice come prova di un intervento del maligno. Il giudice stia bene attento alle materie di tali gomitoli, in genere piume o lana, i quali possono essersi formati rivoltando tutti i giorni i materassi per rifare il letto, oppure può averli lasciati il materasso per incuria. La formazione dei gomitoli per cause naturali è più frequente nei materassi di piume. Se i gomitoli nascondono aghi, l’inquisitore si ricordi che dove ci sono donne, dappertutto ci sono aghi (ubi sunt mulieres, acus ubique abundant), ed è facile trovarli fin nei letti. Non si proceda nemmeno in base alla fama che certe donne hanno di essere streghe poiché, a causa dell’odio popolare contro di esse, succede che una donna, specie se vecchia e brutta, può restare vittima di quella fama. Ancora bisogna avvertire che le donne sono molto superstiziose e dedite soprattutto ai sortilegi amorosi; ma non è detto che una donna che faccia sortilegi o incantesimi per costringere la volontà di un uomo o per guarire un maleficio, sia per ciò stesso “strega formale”. Il sortilegio infatti può realizzarsi senza apostasia della religione e patto col diavolo da parte di una donna, al contrario di come credono certi giudici che, muovendo da questo presupposto, non lasciano intentata alcuna via, anche illecita, per estorcere confessioni. La tortura si può applicare quando ci siano indizi molto gravi. Si esortino le inquisite a dire la verità e non si suggerisca loro alcunché, ma si scrivano soltanto le parole che diranno. Non si dia la tortura con squassi, né si ripeta se non in casi gravissimi e mai superi lo spazio di un’ora. È fatto divieto di radere le imputate per farle confessare. Quando confessano di aver partecipato a convegni notturni e nominano dei complici, non si proceda contro costoro, essendo il più delle volte la presenza delle accusatrici ai giuochi soltanto un’illusione. Il giudice dimentichi ciò che sui ludi diabolici è stato scritto dai dottori, perché si è vista l’applicazione delle loro teorie nuocere gravemente alle accusate e alle persone da esse nominate. Per esempio, riguardo alle misteriose morti dei bambini, può accadere che i piccoli muoiano per soffocazione nel letto della madre o della nutrice, e perciò si proibisca alle mamme e alle balie di tenere i bambini nei loro letti e si raccomandi l’uso delle culle. Ciò considerato i vescovi, i loro vicari e gli inquisitori siano il più possibile cauti nel condurre processi di stregoneria, e considerino bene quanto si è detto per evitare rimproveri nonché punizioni per arbitrarie carcerazioni, inquisizioni e torture.
Le disposizioni del Sant’Uffizio non negano la possibilità di reali tregende con il diavolo; il Sant’Uffizio non specifica come accertare se un certo gomitolo è di provenienza stregonica o naturale, oppure è stato fabbricato addirittura dal diavolo; quali sono gli indizi da considerarsi “molto gravi”, e quali i casi di stregoneria “gravissimi”; quali circostanze possono illuminare sulla realtà o illusorietà delle riunioni ecc. Di contro, è da rilevarsi il tentativo di disciplinare la legislazione comune e di rendere meno dura la procedura penale. Notevole l’atteggiamento di cautela e di ottimismo, il mettere in rilievo le inverosimiglianze nelle storie di stregoneria, per cui occorre un’accurata verifica di tutte le testimonianze. Dall’Instructio prese le mosse Gregorio XV con la sua bolla “ Omnipotentis Dei ” del 20 marzo 1623, con la quale stabiliva che i rei di stregoneria non venissero mandati al supplizio se non fosse provato che avessero fatto morire qualcuno. Gli altri dovevano essere puniti col carcere.
L’Instructio e la bolla dettero risultati positivi, come accadde a Firenze.
Il 21 marzo 1626 il cardinale Giovanni Garcia Villini scriveva da Roma al nunzio apostolico a Firenze, avvertendolo che nella città il Cospi, giudice incompetente, aveva svolto molti processi contro presunte streghe, riconosciute poi innocenti. In seguito l’arcivescovo aveva deputato commissario contro le streghe il canonico Cini, il quale l’anno prima aveva portato davanti alla Congregazione del Sant’Uffizio il caso di una certa Margherita Palagi, detta la Tabossina, «ragazza di non sano giuditio et che andava accattando l’elemosina, et pubblicamente dicendo che la notte con l’altre donne guastava fanciulli et aveva guasto questo et quell’altro che sapeva essere ammalati, affine chiamata per curarli, come faceva con modi et parole vane e ridicole, ne riportasse qualche buona elemosina». Il Sant’Uffizio, esaminati gli atti del processo, constatato di «non potersi dar fede alcuna alle parole della ragazza, né giustamente ritenere le donne carcerate per nominatione di lei», ordinò il ricovero della poveretta in un pio istituto «et si provvedesse di buon confessore et le altre donne si scarcerassero», dando facoltà al Cini «d’impinguare il processo, difettoso anche nella prova de’ corpi de’ delitti». Il Cini cercò altre prove e le presentò a Roma ai giudici del Sant’Uffizio, il quale però dichiarò chiuso il caso della Palagi, non aggiungendo le nuove prove «cosa per la quale si debba recedere dalla risolutione già presa». Il Cini intentò un altro processo, questa volta contro Maddalena Serchia da Certaldo. Era una vecchia mendicante sospettata di aver fatto ammalare un bambino, e perciò era stata battuta e torturata. Tra i tormenti aveva detto che quel bambino sarebbe guarito entro otto giorni, se essa avesse potuto pregare in chiesa davanti a un Crocifisso da cui aveva ottenuto altre grazie. Le fu concesso e «portò il caso che il bimbo in tal tempo prese miglioramento et anche dopo guarì. Et perciò simile vaticinio et effetto seguitone, si è preteso che da patto et arte diabolica provenisse. Ma visto et considerato diligentemente questo et altro dedotto contra di lei, si è giudicato non esservi fondamento alcuno di tal delitto, et si è ordinata la scarcerazione di lei a Mons. Arcivescovo».
- L’Inquisizione in Italia: dalla stregoneria ai “crimini di fede”.
Secondo le ricerche più recenti, l’Italia figura, insieme alla Spagna, come il paese europeo nel quale maturano più precocemente atteggiamenti di cautela e di moderazione nei processi per stregoneria del tutto anomali rispetto alle tendenze prevalenti in quegli anni. Sia i processi di stregoneria, sia gli atteggiamenti favorevoli a una sua dura repressione, si diradano molto presto, già nel corso del terzo decennio del ‘500. Cautela, esigenza di non farsi fuorviare in un campo minato da dubbi e da inganni, necessità di contrapporre regole certe a un indiscriminato furore persecutorio che sale dal basso e trova facile sfogo in giudizi sommari: ecco le linee sulle quali si muove la repressione della stregoneria in buona parte dei tribunali inquisitoriali italiani del tardo ‘500. Le ricerche del Tedeschi (3) hanno definitivamente mostrato la netta propensione dell’inquisizione romana del tardo ‘500 a scelte repressive moderate: la stessa Instructio sarebbe secondo lo studioso un collage di disposizioni precedenti. Per spiegare questo atteggiamento dei giudici italiani, profondamente diverso rispetto a quello dei tribunali di altre zone europee, sono state addotte diverse cause, come l’influsso di modi di pensare propri dell’Umanesimo, oppure la natura “più mite” della stregoneria mediterranea (una delle tesi del Levack, che però non sembra convincente per molti studiosi). Ma la strada che appare più fruttuosa da questo punto di vista è quella che incentra la propria analisi nell’ambito degli aspetti giuridico-procedurali del Sant’Uffizio romano.![]()
In primo luogo, nella trattatistica inquisitoriale italiana una precisa gerarchia di gravità pone la stregoneria in secondo piano rispetto all’eresia, e anche rispetto ad altre forme di magia diabolica, come la negromanzia, per la consapevolezza che si tratta di un crimine di dubbia natura e di difficile verificabilità. Si afferma il divieto di procedere contro i complici del sabba, che appare, ancor più dell’uso moderato della tortura e della riluttanza alle esecuzioni capitali, la misura più specifica e più gravida di conseguenze tra tutte quelle adottate nel tardo ‘500 per arginare gli abusi nella repressione della stregoneria. Nessuno dei giudici di fede italiani di questi anni nega che esseri umani possano, grazie al patto col diavolo, andare in volo al sabba e uccidere bambini e animali, per accennare solo alle più note prerogative attribuite alle streghe moderne. È vero però che nessuno di essi sembra particolarmente preoccupato della loro presenza o propenso a credere con facilità alla realtà delle loro esperienze: prevale il senso della possibilità e del dubbio, la consapevolezza che l’illusione è uno dei poteri più subdoli di cui il diavolo dispone. Ciò si riflette nelle pene inflitte: il carcere. La condanna a morte è legata alla recidiva o all’impenitenza, come per gli eretici, non alle aggravanti specifiche come il maleficio, che una consolidata tradizione giuridica riteneva sufficienti per irrogare la pena capitale alle streghe.
Tuttavia, questo atteggiamento di moderazione sembra contraddetto da un dato. Le attività giudiziarie dei tribunali di Pisa, Napoli e Reggio Emilia, che sono quelli per i quali abbiamo dati più precisi, presentano una netta tendenza all’incremento, sia per le denunce e le informazioni, sia per i processi veri e propri: l’analisi comparata dei dati disponibili tra il 1542 e il 1601, infatti, suggerisce il quinquennio 1597-1601 come la fase repressiva più intensa del secolo, e forse dell’intera storia dell’inquisizione romana. Una svolta silenziosa, ma di incalcolabile portata, stava attrezzando i tribunali di quegli anni per una battaglia nuova, meno cruenta ma più insidiosa rispetto alla grande caccia agli eretici dei decenni centrali del ‘500. L’inquisizione ora uccide di meno, ma processa, indaga, sospetta molto di più, su un territorio più vasto e su un campionario di crimini di fede ricco e vario, anche se a prima vista di scarsa importanza. Il sospetto d’eresia, oltre che sulle superstizioni, si allunga su un insieme di comportamenti, pratiche, idee, che hanno i connotati inequivocabili della quotidianità, del banale. Infrazioni alla precettistica – il mangiar carne nei tempi proibiti, anzitutto – bestemmie dettate dall’ubriachezza e dall’ira, intemperanze verbali, entrano nel raggio d’azione dell’inquisizione e ne diventano lentamente il pane quotidiano. Dunque, la Congregazione del Sant’Ufficio promuove negli stessi anni un più risoluto impegno dei suoi tribunali sul fronte delle superstizioni e una più netta accentuazione delle sue perplessità in materia di repressione della stregoneria.
Dovendo agire su un repertorio di “crimini” più vasto, l’inquisizione romana si avvale della mobilitazione dei confessori. Non era uno strumento nuovo, nella storia dei tribunali inquisitoriali. Le connessioni e le interferenze tra pratica della confessione e repressione dell’eresia ne accompagnano l’operato sin dai primordi, anche se una precisa ricostruzione di quei rapporti non è stata tentata. Ma senza dubbio l’uso della confessione dei peccati era stato presto individuato come uno degli strumenti più efficaci per la lotta all’eresia e alla diffusione dei libri proibiti. Il sistema elaborato era semplice, ma efficace. Il confessore rifiutava di dare l’assoluzione sacramentale ai penitenti macchiatisi di peccati che rientravano tra i crimini di fede, sino a quando essi non si fossero presentati in un tribunale inquisitoriale per ottenervi l’assoluzione giudiziale e per denunciare gli eventuali complici. Formalmente questo meccanismo era rispettoso della norma del “sigillo sacramentale”, cioè del segreto che il confessore doveva mantenere sui peccati confessati. Infatti non era il confessore a divulgare fatti protetti dal segreto. Egli si limitava a non assolvere i penitenti macchiatisi di crimini di fede: era un suo diritto. Spettava al penitente, se voleva essere assolto, recarsi dall’inquisitore, con “autonoma” scelta successiva. Era questa infatti la procedura di un istituto giuridico nuovo, destinato a straordinari sviluppi: la spontanea comparitio, che non riguardava solo i penitenti non assolti, ma chiunque rivelasse a un inquisitore tutti i delitti commessi contro la fede e i nomi di tutti gli eventuali complici. Il denunciante – un antesignano dei collaboratori di giustizia – aveva diritto a vantaggi consistenti: l’esenzione dalle pene temporali (carcerazione, multe, condanne pubbliche infamanti) e, quando l’abiura era inevitabile, dalla pubblicità dell’atto. Il solo castigo che gli veniva inflitto erano le penitenze salutari (digiuno, preghiere, pratica sacramentale più intensa). Da quando era stato introdotto, intorno al 1215, fino agli anni ’30 del ‘500, il ricorso alla penitenza era solo un obbligo da rispettare almeno una volta all’anno, non un’esigenza che si soddisfa tutte le volte che la coscienza lo richiede, come oggi. Molti, per la difesa della propria riservatezza e per diffidenza verso l’uso improprio delle notizie apprese dai confessori, erano soliti comunicarsi senza confessarsi oppure confessarsi in una chiesa e comunicarsi in un’altra, anche nelle piccole comunità di provincia. Così, nell’Italia post-tridentina, nel giro di pochi decenni, un sacramento tradizionalmente malvisto e poco praticato, comincia a occupare spazi crescenti nella vita individuale e associata. La Chiesa seguì questa direzione anche in riferimento ad altri sacramenti, come il matrimonio, per esempio, mirando a un obiettivo ben preciso: migliorare la disciplina dell’intera società.
Note:
1 - Per es. in A. GIARDINA / G. SABBATUCCI / V. VIDOTTO, Nuovi profili storici, Laterza, Roma-Bari 2007, vol. I, p. 484.
2 - M. MURRAY, Le streghe nell’Europa occidentale, Garzanti, Milano 1978.
3 - J. TEDESCHI, The Roman Inquisition and Wichcraft. An Early Seventeenth-Century “Instruction” on Correct Trial Procedure, «Revue de l’histoire des religions», CC (1983).
Bibliografia di riferimento:
- GIUSEPPE BONOMO, Caccia alle streghe. La credenza nelle streghe dal sec. XIII al XIX con particolare riferimento all’Italia, III edizione con una nuova introduzione, Palumbo, Palermo 1985 (I ed. 1959; II ed. 1971);
- GIOVANNI ROMEO, Inquisitori, esorcisti e streghe nell’Italia della Controriforma, Sansoni, Firenze 1990.
Lucrezia Iris Martone,
laureata in Filosofia e in Lettere Classiche (Università “Aldo Moro” di Bari), ha conseguito il Dottorato di Ricerca in “Filosofia, scienze e cultura dell’età tardo-antica, medievale e umanistica” (Università degli Studi di Salerno). Ha curato l’edizione italiana del volume di C. Steel, Il Sé che cambia. L’anima nel tardo neoplatonismo: Giamblico, Damascio e Prisciano (Bari, 2006) e pubblicato vari articoli sul Neoplatonismo pagano di lingua greca, ma sicuramente la sua opera più nota è il De Anima di Giamblico. I frammenti, la dottrina (Pisa, 2014), con la prefazione di H.-D. Saffrey: oltre a fornire la prima traduzione italiana dal greco antico, l’opera presenta i frammenti dell’opera giamblichea secondo un ordine inedito, basato su evidenze filologiche e filosofiche, che mette maggiormente in risalto i nessi tra la filosofia di Giamblico e quella di Plotino e di Porfirio. Attualmente Lucrezia Iris Martone insegna Lettere in una Scuola Secondaria e collabora con la Scuola Normale Superiore di Pisa, dove prosegue la sua attività di ricerca.


 cattolicesimo si stabilì in Roma,ove entrò in forma solenne il 20 dicembre 1655,durante il pontificato di Alessandro VII. Alloggiò dapprima in Palazzo Farnese poi in altre sedi. La bella e coltissima ex-regina raccolse attorno a se una corte composita,dove accanto a letterati,poeti,scienziati ed eruditi di gran valore,si notavano maghi,alchimisti,avventurieri e ciarlatani.
cattolicesimo si stabilì in Roma,ove entrò in forma solenne il 20 dicembre 1655,durante il pontificato di Alessandro VII. Alloggiò dapprima in Palazzo Farnese poi in altre sedi. La bella e coltissima ex-regina raccolse attorno a se una corte composita,dove accanto a letterati,poeti,scienziati ed eruditi di gran valore,si notavano maghi,alchimisti,avventurieri e ciarlatani.



























































 Illustr. 5: La Rosa
Illustr. 5: La Rosa